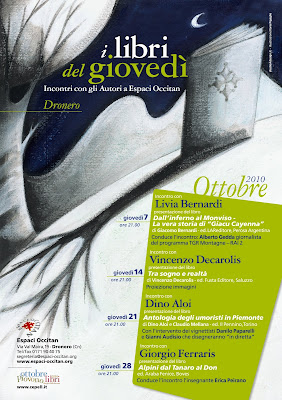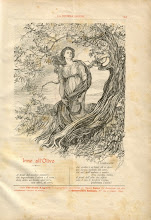Il 28 agosto avevamo pubblicato la lettera aperta all'Ing. De Benedetti sull'ampliamento della centrale Tirreno Power di Vado apparsa su diversi quotidiani. Riceviamo ora e pubblichiamo questo ulteriore contributo che ipotizza una possibile risposta alle tesi avanzate da Tirreno Power e indirettamente a quanto affermato in merito dalla CGIL.
Proposta "Energia e lavoro" sul futuro della centrale Tirreno Power di Vado Ligure
In merito al futuro industriale dello stabilimento Tirreno Power di Vado Ligure, i sottoscriventi propongono alle parti interessate un Progetto che, benchè consapevoli non rappresenti la soluzione ideale per la città di Savona, può riscontare un ampio consenso nelle istituzioni e più in generale nella cittadinanza (soluzione che peraltro ricalca quella già raggiunta 20 anni fa).
La proposta viene incontro a ben 5 dei 6 punti più volte richiesti dalla dirigenza Tirreno Power e dai sindacati (aumento potenza, mantenimento dimensioni di produzione, maggior efficienza produttiva, consolidamento occupazionale, commesse per la costruzione del nuovo gruppo).
Il progetto prevede:
SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI DUE GRUPPI 3 E 4 A CARBONE DA 660 MW (OBSOLETI E RISALENTI A 40 ANNI FA) CON UN NUOVO GRUPPO A CICLO COMBINATO DA 760 MW A GAS NATURALE (PREVIO ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO DEGLI OSSIDI DI AZOTO ANCHE NEL GRUPPO A GAS NATURALE ATTUALE).
Questa proposta va incontro a 5 richieste di Tirreno Power:
AMPIAMENTO POTENZA
1) aumento della potenza totale della centrale di 100 mw (da 1.420 a 1.520 mw), che va nella direzione richiesta di un ampliamento della capacità di produzione energetica;
MANTENIMENTO DIMENSIONI DI PRODUZIONE
2) mantenimento di una potenza complessiva della centrale che permetta, secondo Tirreno Power, di conservare la necessaria massa critica per stare in modo bilanciato sul mercato dell'energia.
Verrebbe quindi meno l’ipotesi prospettata inizialmente dai Comitati di lasciare soltanto il gruppo attuale a ciclo combinato da 760 mw, che secondo la dirigenza Tirreno Power per dimensioni non permetterebbe all’unità produttiva di essere competitiva;
MAGGIORE EFFICIENZA PRODUTTIVA
3) l’efficienza della produzione sarebbe del 58%, e quindi con un aumento notevole rispetto al 30-35% degli attuali obsoleti gruppi a carbone 3 e 4. L’uso del ciclo combinato consente infatti un’altissima resa elettrica, con coefficienti di trasformazione dell’energia termica in energia elettrica molto più elevati rispetto al carbone.
Questo andrebbe incontro a quanto ripetutamente richiesto dalla dirigenza Tirreno Power, e anche dalla cittadinanza (più efficienza significa meno inquinamento a parità di kwh);
CONSOLIDAMENTO OCCUPAZIONALE
4) nella situazione attuale sarebbe comunque inevitabile la dismissione dei gruppi 3 e 4 obsoleti e non allineati alle normative, con conseguente riduzione delle unità occupate. Con l’aggiunta del nuovo gruppo a ciclo combinato invece si otterrebbe il risultato del mantenimento e consolidamento dei livelli occupazionali, venendo incontro in parte alle richieste dei sindacati locali.
E’ previsto inoltre l’utilizzo di un numero significativo di unità lavorative durante il periodo di edificazione del nuovo impianto a turbogas, e di adeguamento dell’impianto a turbogas esistente;
COMMESSE PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO GRUPPO
5) attivazione delle commesse a favore delle aziende specializzate (con preminenza per quelle regionali e locali), per la costruzione del nuovo gruppo a ciclo combinato. Questo verrebbe incontro anche alle richieste più volte manifestate dai sindacati regionali;
MIX DI PREZZO
6) l’unico punto su cui non si potrà andare verso la direzione prospettata dall’azienda (e a cui l’azienda dovrà rinunciare per arrivare a un accordo) è di utilizzare ancora il carbone come combustibile, e quindi su questo punto l’azienda non potrà ottenere un miglioramento del mix dei costi di produzione (che comunque rimarrà ben al di sotto del prezzo di mercato dell’energia, permettendo quindi a Tirreno Power di ottenere comunque un significativo margine di profitto).
D’altronde Sorgenia (la controllante di Tirreno Power) sta ultimando entro l’anno l’apertura in Italia di altre 3 centrali da 800 mw, tutte a gas naturale (e non a carbone).
La dirigenza Tirreno Power dovrà quindi rinunciare a una parte del suo cospicuo utile annuo di esercizio (negli ultimi anni ha anche superato i 100 milioni annui) per arrivare a tale compromesso con la comunità savonese (Regione, Comuni, associazioni, Ordine dei medici, ecc), e per poter ridurre i dati drammatici di mortalità e i costi esterni per il territorio, valutati dalla Cominità Europea (Progetto Externe) in 140 milioni di euro annui in termini di danni sanitari, all’agricoltura, agli edifici, al turismo, alle multe dovute all’eccessiva emissione di CO2.
In sintesi, questa soluzione permetterà, a fronte di una modesta riduzione dei profitti di Tirreno Power, di ridurre di circa il 90% il danno ambientale in termini di inquinamento, riducendo di conseguenza in modo assai significativo i tassi di mortalità prematura della popolazione savonese.

(secondo i calcoli riportati nel grafico del referente scientifico dell’Ordine dei Medici dott.Paolo Franceschi, che è stato consultato per avere un parere tecnico, con questo nuovo progetto si diminuirebbero i livelli di inquinamento delle emissioni di polveri sottili ( PM primario + PM secondario) della centrale di Vado Ligure di circa il 90% sia rispetto allo stato attuale della centrale, e sia rispetto a come sarebbe stata la centrale dopo il progetto di ampliamento prospettato dalla dirigenza Tirreno Power).
Questa non è certamente la soluzione ottimale per la città di Savona e per i suoi abitanti, ma per venire incontro alle esigenze dell’azienda e dell’occupazione i sottoscriventi sono disposti a sedersi finalmente intorno a un tavolo con la Regione, i Comuni, e l’azienda per discutere di questa soluzione, che è l’unica soluzione di compromesso possibile.
In tale accordo, l’azienda rinuncerà quindi al suo Progetto iniziale di ampliamento della centrale a carbone di Vado Ligure, rifiutato dalla quasi totalità della comunità savonese.
Tutte le ricerche internazionali e le direttive comunitarie concordano infatti nel ritenere irricevibile un Progetto atto a costruire (e a far funzionare per altri 50 anni, con effetti devastanti per le nostre future generazioni) un nuovo gruppo a carbone (insieme ai due gruppi già esistenti) vicino a una grande città come Savona, e in un territorio che è già stato sottoposto da decenni a pesantissimi effetti di inquinamento.
CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
Di seguito, gli oneri richiesti a Tirreno Power e dovuti alla cittadinanza e alle istituzioni savonesi, a fronte dell’attivazione di questo progetto alternativo di ampliamento della centrale:
A) prima dell’attivazione del progetto, la dirigenza Tirreno Power, in collaborazione e sotto il controllo degli enti pubblici preposti, deve provvedere a istituire un’efficace e capillare struttura di monitoraggio di misurazione delle polveri sottili, andando anche al di là dei limiti di legge (in particolare per le misurazioni delle pericolosissime PM 2,5) per garantire una maggiore sicurezza per la collettività;
B) prima dell’attivazione del progetto, la dirigenza Tirreno Power dovrà fornire alla Regione e ai Comuni coinvolti un Progetto ben definito e vincolante di sviluppo delle fonti energetiche alternative (in particolare, fotovoltaico e solare).
C) è fortemente auspicabile che Tirreno Power, con altri operatori locali pubblici e privati (Depuratore, Enigas, ecc) e con la collaborazione di Regione e Comuni, avvii una società allo scopo di sviluppare il teleriscaldamento (ovvero il procedimento di riscaldamento di abitazioni, scuole, ospedali alimentato dal calore residuo della centrale a turbogas), come ormai operativo nelle comunità più avanzate dal punto di vista del risparmio energetico.
Questo permetterebbe di ottenere un grande beneficio per la città di Savona, sia in termini di un minor inquinamento (il teleriscaldamento è alternativo alle caldaie delle abitazioni), sia di un maggior risparmio sul costo del riscaldamento per le famiglie, e sia di una maggior crescita occupazionale legata all’attuazione di questo alternativo procedimento di riscaldamento abitativo.