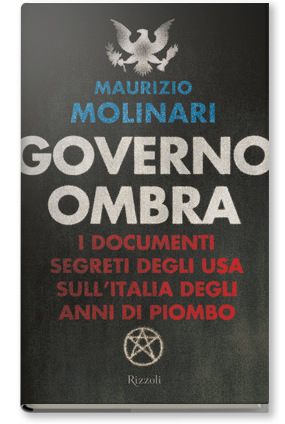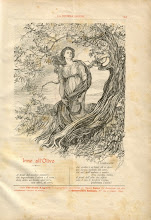Questo
personaggio ha solo una speciale richiesta,
che fa per perpetrarsi nel tempo e nel ricordo di
altre generazioni, eternizzare la sua essenza
mutandone la forma, come avviene per ogni immortalità
simbolica: chiede che il suo nome resti segreto. In caso
contrario egli sparirebbe, e con lui il
mondo che lo ospita. È il dybbuk di Walter
Benjamin: l’«omino con la gobba» che troviamo
nascosto anche nell’automa giocatore di scacchi
della prima Tesi sul concetto di storia. «È noto che
sarebbe esistito un automa costruito in un modo tale da
reagire ad ogni mossa di un giocatore di scacchi
con una contromossa che gli assicurava la
vittoria.
Un manichino
vestito da turco, con una pipa in bocca, sedeva davanti alla
scacchiera, posta su un ampio tavolo. Con un sistema di
specchi veniva data l’illusione che vi si potesse guardare
attraverso da ogni lato. In verità c’era seduto dentro
un nano gobbo, maestro nel gioco degli scacchi, che
guidava per mezzo di fili la mano del manichino. Un
corrispettivo di questo marchingegno
si può immaginare nella filosofia. Vincere
sempre deve il manichino detto «materialismo
storico».
Esso può competere
senz’altro con chiunque se prende al suo servizio
la teologia, che oggi, com’è a tutti noto,
è piccola e brutta, e tra l’altro non deve
lasciarsi vedere». Ma questo «nano gobbo», per ammissione
dello stesso Benjamin, è in realtà un suo
«doppio», il dybbuk che lo possiede e lo
spinge a fare ciò che vuole, così dirà nel suo saggio
Avanguardia e rivoluzione, citandolo
come imparentato ai personaggi scanzonati,
vagabondi e gioiosi di Robert Walser «che si
muovono nella notte, dove essa è più nera; una notte
veneziana, se si vuole, illuminata dai deboli
lampioni della speranza, con qualche luce di gioia
negli occhi».
Il dybbuk, nella
tradizione popolare ebraica polacca e tedesca,
è lo spirito disincarnato al quale è stato
vietato l’ingresso in paradiso per aver commesso
peccati mortali, come il suicidio per amore. Ad
alcune di queste anime, per imperscrutabili
motivi, viene data la possibilità di emendarsi
condividendo l’anima di un altro corpo, ed avere
così una seconda possibilità.
Nelle vecchie
sinagoghe di Berlino, quando Benjamin era
ancora bambino, si narrava anche che i dybbuk
fossero fuggiti dalla gehennaa, un termine
ebraico traducibile liberamente con «luogo
dei miasmi». Ma ciò che dà il senso ultimo del dybbuk
è l’etimologia della parola, che deriva dall’ebraico
davok, «attaccarsi»: il dybbuk dunque è un
qualcosa che si attacca ad un vivente per coabitare
in esso, in senso ampio una «possessione». Questa
simbiosi forma un dibbukim, ed è così che
descrive la propria relazione con l’«omino gobbo» il
filosofo berlinese in una lettera all’amico
Gershom Scholem: «conserva le mie immagini, io
non posso dividermi da lui», come ad evocare qualche
cosa di determinativo per tutto il suo essere.
Cercai di
contenerla restando fedele non al criterio della
causale irrecuperabilità biografica
del passato bensì a quella, necessaria, di
ordine sociale. Ciò ha comportato che i tratti
biografici che si delineano piuttosto nella
continuità che nella profondità
dell’esperienza, in questi brani restino del tutto sullo
sfondo. E con essi le fisionomie — quelle della mia
famiglia al pari di quelle dei miei compagni. Mi sono
invece sforzato di impadronirmi di quelle immagini
in cui l’esperienza della grande città si sedimenta in un
bambino della borghesia. Ritengo possibile
che a tali immagini sia riservato un particolare
destino. Non sono ancora attese da forme ben modellate come
quelle di cui, nel sedimento della natura, da secoli
dispongono i ricordi di una infanzia trascorsa
in campagna. Le immagini della mia infanzia
nella grande città invece sono forse idonee a preformare
nel loro intimo l’esperienza storica successiva.
Almeno in queste, spero, appare comprensibile
quanto colui di cui qui sui parla in una fase successiva
fece a meno della sicurezza che era toccata alla sua
infanzia».
Così Walter
Benjamin motiva la ricerca delle sue immagini-guida
nell’introduzione di Infanzia berlinese. Qui il
tema del ricordo, della recherche di tipo proustiano, si
alimenta, ma solo in apparenza, di un percorso
metropolitano che, però, finisce
inevitabilmente per convergere verso
quel personaggio attorno al quale, per esplicita
ammissione e scelta dell’autore, gravitano
tutte le immagini capaci di «preformare nel loro
intimo l’esperienza storica successiva». Qui
Benjamin allude, ancora una volta, alla «debole forza
messianica» di certe immagini, forse in grado di
salvare un futuro presente sul quale già si stendeva
minacciosa l’ombra incombente del nazismo. Theodor
Adorno bene identifica questo nesso quando, nella
postfazione alla prima edizione della raccolta
afferma: «Infanzia berlinese è stata scritta
all’inizio degli anni Trenta… Le immagini che il libro fa
emergere fino ad una sconcertante vicinanza, non
sono né idilliache né contemplative. Su
di loro si stende l’ombra del reich hitleriano. Come in
sogno, congiungono l’orrore che questo suscita
a ciò che è stato. Di fronte alla dissoluzione
del proprio passato biografico, l’intellettuale
borghese, con terrore panico, prende consapevolezza
di se stesso come parvenza».
E cosa ci può essere di
più parvente, fantasmatico, ma al tempo stesso
reale e permanente, di un personaggio
infantile con il quale si è colloquiato durante
i lunghi anni della propria formazione
psichica? La sua centralità è tale,
nell’economia di Infanzia berlinese e non
solo, che Adorno, nella postfazione, dice chiaramente
che: «L’omino con la gobba doveva servire da conclusione».
Dunque nel rito
messianico che Benjamin amministra attraverso l’accurata scelta
delle immagini, all’«omino con la gobba» viene affidata una
promessa di salvezza
La scansione delle
immagini di Infanzia berlinese, infatti, ci
guida verso l’«omino con la gobba» attraverso la
descrizione di luoghi definiti, come il
Kaiserpanorama, un precursore del
cinema con immagini da vedere attraverso stereoscopi
davanti ai quali sedevano gli spettatori, o i
ricordi del Tiergarten, il grande parco al centro
della città con i suoi favolosi animali, la lontra,
i pavoni le farfalle, o della sua casa immersa nella
luce lunare che «non è destinata al nostro vivere
diurno», con tutto il corteo domestico di armadi,
calzini, la scatola con gli strumenti per cucire,
o il telefono che, all’epoca, se ne stava «incompreso
ed esiliato». Dunque nel rito messianico che
Benjamin amministra attraverso l’accurata
scelta delle immagini, all’«omino con la gobba» viene
affidata una promessa di salvezza.
Dopo queste
«stanze», a mo’ di introduzione, ecco ad un
tratto apparire un essere, una entità, totalmente
distinta, un totaliter aliter cui Benjamin,
inaspettatamente, attribuisce il ruolo
di alter ego, ma di un tipo affatto particolare, dato
che è lui a vedere, senza essere visto, tutte le
immagini precedenti: «Quando compariva
restavo con un palmo di naso (nell’originale tedesco
Benjamin usa l’espressione das Nachsehen
haben, alla lettera «seguire le cose con lo sguardo»).
E intanto le cose si ritraevano, sino a che, passato
un anno, il giardino divenne un giardinetto, la mia
camera una cameretta, la panca una panchetta. Le cose si
assottigliavano, ed era come se spuntasse loro
una gobba che le assimilava all’omino. L’omino mi
anticipava sempre. E nell’anticiparmi
intralciava il mio cammino. In realtà non faceva che
riscuotere di ogni cosa cui volgevo la mia attenzione,
la metà del dimenticare… Fu sempre solo lui
a vedere me. Mi vide nel nascondiglio e davanti
al recinto della lontra, nei mattini d’inverno e davanti
al telefono…».
L’«omino gobbo»
dunque, assimila progressivamente il
mondo visionario ed infantile di Benjamin
nella sua gobba, riscuotendo inoltre la «metà del
dimenticare». Ecco perché il filosofo, alla
fine, lo ritiene il suo dybbuk, una entità che vive con lui,
che condivide i sui pensieri più nascosti,
ed anche che li protegge dalla storia nella sua mistica
gobba. Come non richiamare un’altra immagine-guida di
Benjamin, quella dell’Angelo della storia con il
volto alle macerie del passato e le ali già
spiegate verso il futuro?
Non è forse il
mondo che l’omino con la gobba preserva nella sua
deformazione a costituire il possibile
futuro verso il quale l’Angelus Novus viene spinto? Come dirà
delle immagini-costellazione nei suoi Passage parigini,
l’«omino con la gobba» vive in un luogo in cui «un’epoca
sogna la successiva».
Tutto ciò che si
produce nell’ebraismo, ha scritto Rosenzweig in La
stella della redenzione, comporta una doppia
relazione, da una parte con questo mondo e dall’altra
con un mondo che deve venire: Benjamin ricava il suo
spazio in questa tradizione. Ecco perché
l’«omino con la gobba» di Infanzia berlinese,
nascosto nel buio notturno della cantina, così come
il suo corrispettivo nascosto nel buio
dell’automa giocatore di scacchi nelle Tesi sul
concetto di storia, verrà da Benjamin
continuamente citato, richiamato,
allusivamente evocato in una pluralità
di saggi, come quello su Kafka, al fine di essere poi utilizzato
come veicolo metaforico, affidabile
proprio per la sua specificità formale,
per quella carica proiettiva che in Benjamin,
come in tutti i grandi visionari, cambiava di
polarità mutando la deformità in salvezza.
La genia dell’omino con la gobba. Ma chi erano i sodali dell’«omino gobbo», la sua genia occulta, nascosta nella buca del palcoscenico infantile del filosofo berlinese? Tra quali personaggi della tradizione ebraica egli lo aveva scelto per la capacità di trasformare in visione messianica le angustie e le paure della sua vita errabonda, in deflusso escatologico le ansie infantili? Il filo sottile che lega questi personaggi viene costantemente evocato da Benjamin come in una formula alchemica, in cui ciò che si legge non corrisponde a nulla di fruibile se non per un iniziato che possegga la chiave di lettura. L’«omino gobbo» appartiene, lo abbiamo accennato, a quella stirpe di figure che Benjamin riferisce all’arte di Robert Walser; in specifico a quella parte che «ci rivela donde provengono i suoi diletti. E cioè dalla follia, e basta».
Si tratta però di una
forma di «follia» particolare, più
definibile come «mania», avrebbe detto Platone nel
Fedro (244 A-C), come quella che «viene dalle Ninfe», che porta
i doni più ambiti, una follia che «illumina».
Anche in una lettera al suo amico Gershom Scholem, Benjamin scrive che «la follia è l’essenza dei personaggi di Kafka; da Don Chisciotte, agli assistenti, fino agli animali», e aggiunge che solo l’aiuto di un folle è veramente un aiuto.
«Vi è, come dice
Kafka, un’infinita speranza, solo non per noi». Ecco che il
dybbukim Walter Benjamin-omino con la gobba, al tempo
stesso lui e non lui, può lanciare uno sguardo
sull’infinita speranza. Nel saggio su Kafka, Benjamin
ci spiega che «questo ometto è l’inquilino della vita
distorta; e svanirà quando verrà il Messia, di cui
un gran rabbino ha detto che non intende mutare il mondo con la
violenza, ma solo aggiustarlo di pochissimo».
E allora, questo «aggiustare di pochissimo»,
questo raddrizzare i torti, come forse la gobba
dell’omino, mettono il personaggio «kafkiano»
in diretta relazione col Messia.
Il «gran rabbino»
a cui Benjamin fa riferimento è Rabbi
Nachman di Breslav, uno dei padri fondatori del
chassidismo, il movimento mistico popolare
che vedeva la speranza palingenetica
depositata negli emarginati, i folli e gli
inetti. Rabbi Nachman sosteneva, con disarmante
semplicità, che «la venuta del Messia non cambierà
nulla, salvo che ognuno si accorgerà della propria
insipienza».
Da questo
riferimento capiamo anche l’attitudine di Benjamin
rispetto al mondo misterioso dell’infanzia, a quei
segreti nascosti all’interno della gobba dell’omino come
nel buio dell’automa giocatore di scacchi. Per
questa corrente del misticismo ebraico, infatti,
il solo nominare questi segreti senza svelarli,
poteva affrettare l’avvento dei tempi messianici.
Per capire il chi è dell’«omino con la gobba» si deve
dunque tornare alle visioni infantili che egli
ritrovava nelle esperienze con l’hashish, dove ad un
certo punto dice: «La maleducazione è il
dispiacere che il bambino prova per il fatto di non essere
capace di magia. La sua prima esperienza del mondo non è che
gli adulti sono più forti, ma la sua incapacità di
praticare la magia».
L’«omino con la gobba» è dunque un essere favoloso che ci riporta ai momenti estatici, aurorali, dell’entusiasmo infantile: il tempo del mistero e del segreto, quando «tutto era ancora possibile».
«Non crediate il
destino sia più che l’intensità dell’infanzia» dice Rilke,
e nessuno più di Benjamin, che ha teso tutta la
sua vita tra le polarità di una fede politica
materialista e una religiosità
mistica, può capirlo.
Anche nel romanzo di Elias Canetti Auto da fé (nell’originale Die Blendung, accecamento), compariva un gobbetto giocatore di scacchi, l’ebreo Fischerle, anche lui simbolo del legame che l’uomo deve avere con le rovine del passato se vuole progettare il futuro. Sia per Benjamin che per Canetti, allora, l’«omino gobbo» è il fantasma dell’identità che per nascondersi e salvarsi, ma anche per agire sottilmente sul mondo, deve prendere forme deformi.Sullo sfondo di queste storie si stagliano infine figure come quelle del Golem, creato da Jehuda Löw ben Bezalel, rabbino in Praga nel sedicesimo secolo, o dell’Homunculus di Paracelso: simulacri di vita prodotti artificialmente ed al servizio del loro padrone certo, ma solo in quanto animati dalle stesse forze mistiche che donano la vita, o la morte, agli esseri umani che li hanno concepiti.
La confessione
Questa chiave di
lettura intima, personalissima, ci viene
data da Benjamin in punto di morte, come estrema
confessione che ritroviamo in una lettera alla
adorata Gretel Adorno, alla quale ha affidato il
segreto dei suoi ricordi. Siamo qui a poche ore della morte
suicida, nel Settembre del 1940 a Port-Bou in
Spagna, mentre tentava di emigrare negli Usa.
Benjamin ha con sé una borsa nera nella quale, forse, si
trova la stesura finale, «assoluta» dirà lui, delle
Tesi, che egli vedeva come premessa necessaria al
grande affresco dei Passage.
Il suo stato d’animo
è ben descritto dalla lettera nella quale ritorna il
contenuto intimista delle immagini di
Infanzia berlinese: «Per quanto concerne la tua
richiesta di appunti che possano risalire alla
conversazione sotto gli alberi di marronniers,
ebbene, si è presentata in un momento in cui
proprio quegli appunti mi hanno dato da fare. La guerra,
e la costellazione che l’ha portata con sé,
mi ha condotto a mettere per iscritto alcuni
pensieri che posso dire di aver tenuto per almeno vent’anni
custoditi in me, anzi preservandoli pure da me
stesso. Questo è anche il motivo per cui persino
a voi non ho concesso altro che un fuggevole
sguardo su di essi. La conversazione sotto
i marronniers fu una breccia in questi
vent’anni. Ancora oggi te li consegno più come un
mazzetto di erbe sussurranti messe insieme in
passeggiate meditative che come una raccolta
di tesi (…).
Esse mi fanno supporre
che il problema del ricordo (e dell’oblio), che vi appare ad
un altro livello, mi terrà occupato ancora per molto tempo».
In realtà egli non ebbe tutto il tempo che avrebbe voluto, pochi
giorni dopo una dose di morfina lo stroncherà, ma nella
missiva respiriamo l’aria che aleggia intorno ai
misteriosi personaggi che vengono direttamente
dai giorni dell’infanzia, la loro scaturigine
onirica ed allusiva, che li rendeva passage dei
pensieri segreti che solo in punto di morte Benjamin
si era deciso a svelare. E allora capiamo che la
preghiera finale di Infanzia berlinese dedicata
al personaggio kafkiano, è in realtà per
se stesso: «Prega bambino mio, per l’omino con la gobba
prega Iddio».