Renoir, La lavandaia accovacciata
Raffaele K. Salinari
La bella lavanderina,
grande madre pop
Archeologia culturale
di una filastrocca, significati, allusioni, spiritualità, cortili
disegnati col gessetto
«La bella lavanderina,
che lava i fazzoletti, per i poveretti, li metta ad asciugar. Fai un
salto, fanne un altro, fai la riverenza, fai la penitenza: orsù,
orsù, dai un bacio, a chi vuoi tu!». Nel testo della nota
filastrocca popolare La bella lavanderina, che tutti abbiamo
recitato da bambini, sono contenute diverse immagini che brillano e
compaiono su quel limite indistinto, e per questo potenzialmente
simbolico e poetico, che separa, o per meglio dire meglio
ricongiunge, il sacro al profano.
Giorgio De Santillana,
nel suo celeberrimo Mulino di Amleto, sostiene come nelle fiabe,
nelle filastrocche, nei miti, siano spesso contenute le visioni di
civiltà antiche, addirittura relitti di interi assetti cosmologici
oggi dimenticati, come quelli precedenti la precessione equinoziale e
dunque al cambio dell’eclittica. A questo proposito porta come
esempio, tra gli altri, la caduta della Ganga (strettamente
femminile) il fiume sacro della spiritualità induista, sulla testa
dello Yogi cosmico Shiva. Non è questa la sede per approfondire il
mito, ma chi volesse farlo lo troverebbe altamente significativo
della tesi sostenuta dallo studioso.
Tornando alla nostra
filastrocca non ci è dato sapere se La bella
lavanderina risponde a criteri così arcaici, ma certo contiene
elementi molto antichi che collocano i gesti via via descritti e
suggeriti in una prospettiva il cui recupero è di importanza
fondamentale per il futuro dell’umanità: la figura della Dea Madre
e una gestualità che ne onora il Sacro e l’Eros come parte di
esso. È infatti più che evidente come la progressiva
materializzazione dei rapporti tra individui e tra individui e Mondo,
la ingravescente prospettiva del Regno della Quantità, come la
definiva il Libero Muratore René Guénon nell’omonimo libro, sta
portando l’umanità oltre ogni equilibrio esistenziale, sia sul
piano fisico sia su quello metafisico, e che il recupero di antiche
figure di una spiritualità senza dogmi ci può aiutare a non
oltrepassare il punto, già molto vicino, di non ritorno.
Cominciamo allora dalla
figura centrale: «la bella lavanderina». Non è affatto azzardato
vederla come una ipostasi pop della Grande Madre, della Grande
Potnia, secondo la descrizione che ce ne da Umberto Pestalozza nel
suo Eterno femminino mediterraneo. Qui, infatti, oltre alla decisiva
affermazione della sacralità espressa dalla Grande Madre attraverso
tutte le donne, le «piccole potnie», troviamo due caratteristiche
che vengono evidenziata nella «bella lavanderina»: la bellezza
certo, segno principe di una cosmesi che diviene cosmologia. Le
genealogia che lega questa idea del Cosmo alla Bellezza è
antichissima e procede da una genealogia che passa attraverso la
Tanit cartaginese, la Demetra greca, Ishtar ed Inanna a Babilonia e
via enumerando sino alla Madonna.
Ma è soprattutto
l’umiltà della «bella lavanderina» che colpisce: questo è il
segno troppo spesso trascurato, ma di fondamentale importanza, per
l’abbinamento della Bellezza alla Saggezza. Umile si riferisce
all’humus, al principio generativo terrestre, a quell’«umido
radicale» che gli alchimisti ricercano come caratteristica della
loro Prima Materia e che dunque, per la legge dell’analogia propria
al linguaggio simbolico, deve corrispondere alla postura dello
spirito di chi vuole l’accesso alle Verità ultime dell’Essere.
L’attitudine umile
della «bella lavanderina» si evince evidentemente dal suo gesto di
«lavare i fazzoletti per i poveretti», e di metterli ad asciugare
al sole. Chi frequenta la simbologia ermetica conosce bene questa
immagine del lavare e del lasciar asciugare, una ennesima forma del
Solve e Coagula, ma questo ci porterebbe forse troppo lontano, così
come una analisi seppur appena accennata di quell’oggetto, oramai
imbalsamato solo in alcuni taschini, che è il fazzoletto. Quante
immagini sensuali sono legate ad esso! Dalla gelosia di Otello al
sensuale lasciarlo cadere affinché venga raccolto e restituito.
Oltre alla biancheria intima, questo accessorio di abbigliamento è,
infatti, il più vicino al corpo. Questo pezzo di stoffa è così
pronto ad impregnarsi di odori ed aromi, naturali o artificiali, dal
sudore al sangue, dagli umori erotici ai profumi più inebrianti. Per
i più tradizionalisti cultori della gangia, basti citare il
significato del safi che si mette all’imboccatura del chilum.
Restando al nostro tema, oltre a ricordare la canzone «amor dammi
quel fazzolettino, alla fonte lo vado a lavar», che riprende in toto
il tema di aperture della «bella lavanderina», il «fazzoletto di
un poveretto» nelle mani della «bella lavanderina», rappresenta
tutto il carico di povertà e degrado delle loro vite, ed il lavarlo
diventa un vero e proprio battesimo lustrale per interposto oggetto,
un gesto catartico potente ed altamente sacro.
Fai un salto, fanne un
altro
Di fronte a questo
verso della filastrocca non possiamo che pensare al «gioco del
mondo», quella serie di dieci case che collegano, attraverso i salti
ed il tiro dei dadi, la Terra al Cielo. Al proposito cominciamo con
l’osservare come alcuni giochi, comuni a tutti i bambini del mondo,
esprimono descrizioni profonde dell’anima mundi, al di là delle
distanze tra culture. Ad esempio, colpisce l’analogia tra il gioco
del mondo (il gioco del mondo!) – detto anche Campana o Rayuela in
spagnolo, che si trova in tutte le culture – e le Sefirot della
Cabbala ebraica. Lo schema è lo stesso, ma anche il percorso della
conoscenza è uguale. Il bambino, come il saggio, deve superare delle
prove per arrivare alla testa dello schema, quella che nella
descrizione cabbalistica dello Zohar viene chiamata Keter ‘Eliyon:
la «Corona Eccelsa di Dio… che giace oltre la nostra comprensione
razionale» (Zohar, XVII). Eppure i bambini ci provano e, con i loro
salti – gridando di gioia istintiva, pura e non condizionata –
finalmente ci arrivano; ad un certo momento della nostra vita ci
siamo arrivati tutti, anche se oramai ci siamo scordati (scordati…
come fossimo uno strumento non più in grado di suonare la melodia
che ci è stata consegnata).
Il «gioco del mondo» è,
allora, un percorso spirituale che, da secoli, viene indagato
razionalmente senza riuscire a penetrarne il significato. Eppure,
quanto semplice sarebbe dire che il Mondo è realmente un gioco; con
questo tutto sarebbe più chiaro, e la manutenzione dello spirito
assicurata. Dice Mircea Eliade: «I bambini continuano a giocare al
gioco della Campana, senza sapere di ridare vita ad un gioco
iniziatico, il cui scopo è di penetrare e riuscire a tornare fuori
da un labirinto; giocando alla Campana i bambini scendono
simbolicamente agli inferi e tornano sulla terra».
A questo punto, forse,
alcuni potrebbero tacciare queste riflessioni di mera casualità; Un
caso, una banale analogia tra Rayuela e Sefirot, tra il
«gioco dei nomi di Dio» ed il gioco del mondo? Ma cosa significa
caso? Forse una necessità della quale non riusciamo ancora a
cogliere l’intimo significato. Prova ne sia il fatto che, spesso,
nell’interpretazione di passi oscuri del Midrash ebraico, viene
utilizzato il potere vaticinante dei bambini, capaci ancora di vivere
tra gli opposti, di soffermarsi «là dove si situa la vita». Fai un
salto, fanne un altro… Questo apprese Rabbi Loewe, celebre rabbino
in Praga, creatore, secondo la leggenda, del mitico Golem – il
servitore di fango descritto già nella Bibbia – che si ribellò,
come tutti gli esseri di fango, al suo padrone.
Ritrovare allora
questa «infanzia dello spirito» nello «spirito dell’infanzia»,
ci interessa come presupposto politico, perché è oramai chiaro che
gli adulti alienati generano soltanto confusione e disarmonia. Certo,
i bambini sono centrali, a parole, in ogni concezione adulta dello
Spirito, ma solo come corpi di passaggio, nei quali esso si
manifesterebbe inconsapevolmente. L’età della cosiddetta maturità
discrimina e divide, è «diabolica», dal greco dia-ballo separare,
quella infantile non discrimina è, dunque, simbolica, da sin-ballo
riunire. L’importanza apparentemente casuale che le cose hanno per
un bambino – la sua indifferenza tra materiale ed immateriale,
organico ed inorganico – diurno e notturno, reale o immaginale,
rappresenta questo punto di vista unificante. Per questo, dalla
Cabbala ai Veda, dai Sufi musulmani ai mistici cristiani, la
manifestazione della scintilla che vitalizza l’anima mundi, può
essere percepita solo da una natura «infantile». Non è liberatoria
la scena di Mary Poppins in cui il padre dei ragazzi, appena
licenziato, saltella via dall’austera sala del consiglio di
amministrazione col suo ombrello strappato? Sarà quello il momento
della sua ritrovata serenità profonda, dell’amore per i figli.
Fai la riverenza
Fare la riverenza era
un gesto che si insegnava alle ragazze di buona famiglia in segno di
rispetto verso qualcuno ma, a differenza dell’inchino, gesto rigido
e formale più decisamente maschile e gerarchizzante, anche per
sottolineare, con quell’atteggiamento aggraziato del corpo, una
forma di equilibrio interiore, segno di una segreta e profonda
armonia. Già questa semplice distinzione, diremmo oggi di genere,
tra due atteggiamenti di rispetto, fanno comprendere come la
percezione e l’espressione del Sacro sia più naturalmente
appannaggio della sensibilità femminile, o meglio di quella parte
del femminile che vive in ogni essere vivente, la parte che «porta
ad effetto» la forza creatrice.
E allora, per comprendere
la profondità simbolica della riverenza, il suo significato per così
dire archetipico, dobbiamo in primis riferirci al concetto di Sacro.
Per una schematica definizione di un campo così vasto, perché
onnipervasivo della realtà sottile dell’esistenza, o meglio così
avvolgente l’esistenza stessa, sono infatti le cose ad essere nello
Spirito e non questo nelle cose, possiamo limitarci a riferire la sua
originaria etimologia di sacer cioè separato, rinviando il
resto all’omonimo libro di Rudolf Otto. Ma questa separatezza non
significa in nessun caso esclusione dalla possibilità di poterlo
percepire, anzi, rappresenta solo (solo!) l’unico mezzo per farlo.
In poche parole, si deve entrare nel Sacro attraverso la percezione
della sua separatezza e poi prepararsi ad affrontare il cammino che
ad esso ci ricongiunge.
Ogni spazio dedicato allo
Spirito è uno spazio sacro, la cui sacralizzazione deriva proprio da
questa separatezza dal mondo profano, cioè letteralmente dalla
realtà puramente materiale che resta o dovrebbe «restare fuori dal
Tempio». Le Chiese sono, o dovrebbero essere, spazi sacri, nei quali
si entra non semplicemente attraversando una porta, non a caso che si
apre sempre verso il suo interno, ma inginocchiandosi di fronte al
Mistero, segnandosi allo stesso tempo. Questo atteggiamento del corpo
predispone dunque all’incontro col Sacro, con il totaliter
aliter che, però, informa di Sé tutto. Nei templi della Libera
Muratoria lo spazio sacro si crea ogni volta, con rituali che,
anch’essi, predispongono attraverso la postura dei corpi, a farsi
attraversare dalla luce dello Spirito.
Ma, e qui sta la
specificità della riverenza, ci sono gesti che servono a evidenziare
la presenza dello Spirito, del Sacro attraverso la Bellezza anche
nella quotidianità di spazi profani, posture che hanno, seppure per
un solo istante, il potere di sacralizzare l’aura di chi li compie;
l’inchino è uno di questi, perché? Perché esso ha, come abbiamo
detto, il potere di suscitare la grazia, o meglio le Grazie. Queste
divinità fondamentali, nominate nella Teogonia di Esiodo
(907) sono le inseparabili compagne di Venere e ne rappresentano, per
così dire, le qualità. Sono Aglaia, l’Ornamento ovvero lo
Splendore, Eufrosine, la Gioia o la Letizia, e Talia, la Pienezza
ovvero la Prosperità. Se cosmo e cosmesi hanno la stessa matrice
linguistica, significa che l’equilibrio tra le cose ha bisogno di
Bellezza; se poi tutto questo è legato allo splendore, cioè alla
luce come simbolo della conoscenza, la triade ci mostra già una
strada da seguire. La Gioia poi, cioè quel sentimento di felicità
che nasce dal condividere con umiltà l’equilibrio raggiunto, ed
infine la Pienezza, cioè la realizzazione di se stessi in tutte le
proprie potenzialità in armonia con il resto delle vite, completano
il quadro di una riverenza ben fatta.
Ecco, allora che un gesto
che le contiene tutte, un gesto aggraziato come dovrebbe essere la
riverenza, evoca quell’Afrodite anima del Mondo che Plotino ci dice
essere l’Essenza stessa delle cose. Ma non basta: come ci ricorda
Davide Susanetti nel suo Luce delle Muse, le Grazie sono strettamente
legate alle Muse, queste «splendide ragazze dall’animo concorde»,
figlie di Zeus e Mnemosine, la Memoria. Create dalle due divinità
per rendere stabile il Cosmo, esse formano un’unica voce. Dimorano
nell’Olimpo insieme alle Cariti, alle Grazie, e ben si comprende
perché siano loro compagne, insieme a Desiderio, unica presenza
maschile. Così nella reggia celeste le Muse e le Grazie, non cessano
di rallegrale la mente del loro padre, «come se il loro compito
fosse di rifare in perpetuo la storia del mondo, di fissare la forma
dell’universo nella trama di una voce che mai si interrompe».
Naturalmente, e questo
invece pertiene molto ad una certa cultura della colpa, dopo la
riverenza, cioè un gesto aggraziato che attira lo sguardo ed ha,
come abbiamo visto, una certa connotazione erotica, non può mancare
la penitenza, cioè, appunto, il gesto che esprime il senso della
colpa, del peccato per aver ceduto alle lusinghe del mondo.
Orsù dai un bacio a
chi vuoi tu
Ma, la penitenza dura
poco, quasi un atto dovuto per allontanare da sé i beghini
benpensanti, i sessuofobi che vedono nell’energia erotica
l’impossibile da governare. Ed ecco che finalmente, sbrigata
l’incombenza, senza partecipazione dell’anima che ancora aleggia
libera nell’aura della riverenza, anzi caricati da questa, si
arriva al bacio, per di più «a chi vuoi tu», pienamente titolari
delle proprie scelte erotiche, un compimento del percorso iniziato
con la figura della «bella lavanderina» che si conclude con il
gesto amoroso per antonomasia. E così si chiude il gioco del mondo
che la filastrocca ci ha fatto percorrere, le sue case sono state
tutte esplorate ed in ognuna abbiamo trovare una risposta e, forse
ancora più importante, una nuova domanda per ricominciare il gioco.
Il manifesto/Alias – 9
aprile 2022
)%20(z-lib.org)-1_pages-to-jpg-0001.jpg)
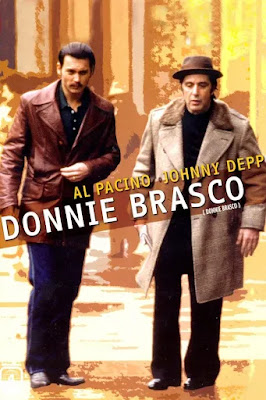
.jpg)












