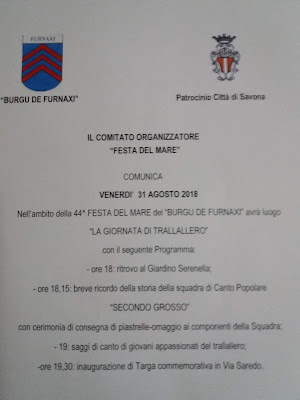Particolare del «Ponte del capello». Santa Maria in Piano, Loreto Aprutino
È l’hybris, la
sfida arrogante ai limiti imposti dalla natura e l’ottusità che
sempre l’accompagna ciò che ha sempre causato i disastri più
grandi.
Raffaele K. Salinari
La metafora del ponte, sinonimo di
inferno dalla notte dei secoli
Il termine pontos,
da cui deriva la parola «ponte», designava, per la Grecia classica,
al contrario di thalassa o pélagos, l’alto mare,
l’ignoto del largo, lo spazio marino nel quale non si vedono le
coste e che sembra confondersi, nelle notti senza luna né stelle,
con il cielo scuro; il termine descrive anche il fondo marino, nel
senso di un incommensurabile baratro.
Per questo pontos veniva
usato come una delle denominazioni del mondo infero, del Tartaro, con
il quale confinava attraverso comuni «radici», poiché in entrambi
nessuna direzione è stabilita e possibile e un’incudine di bronzo
può cadere senza arrivare mai da nessuna parte: «Voragine immensa,
né in tutto il corso di un intero anno uno giungerebbe a terra, se
prima si trovasse dentro alle porte, ma qua e là lo trascinerebbe
tempesta sopra tempesta dolorosa». dice Esiodo nella sua Teogonia.
Nel Mazdeismo il
«battesimo nelle piscine di Persepoli» serve per incontrare «qui
ed ora» la propria Daena, lo spirito guida di ogni essere umano, sul
Ponte Chinvat: «Alla domanda dell’anima stupefatta, che chiede ma
chi sei? alla fanciulla che avanza all’ingresso del Ponte Chinvat e
la cui bellezza risplende più di ogni altra bellezza mai intravista
nel mondo terrestre, essa risponde: sono la tua propria Daena – ciò
che vuol dire: io sono in persona la fede che hai professato e quella
che te l’ha ispirata, quella per cui hai garantito e quella che ti
ha guidato, quella che ti ha riconfortato e quella che ora ti
giudica, poiché io sono in persona l’Immagine voluta infine da te
stesso. Non è nel potere di un essere umano distruggere la propria
idea celeste, ma è in suo potere tradirla, separarsene, non avere di
fronte a sé, all’ingresso del Ponte Chinvat, che la caricatura
abominevole e demoniaca del suo io abbandonato a se stesso».
Chinvat, allora, è il
nome che porta ogni ponte: ogni passaggio necessario e
pericoloso: opus periculosum maxime dicevano i Romani, per
i quali alla gestione del sacro Pons Sublicius, il più antico di
Roma, era preposto il pontifex maximus, cioè la più alta
carica sacerdotale. In queste ascendenze antiche riconosciamo,
allora, al tempo stesso, sia la consapevolezza della sua necessità,
sia della sua fragilità come ogni opera umana corrosa dal tempo.
Ponte Chinvat
Ce lo ricorda anche Ernst
Jünger quando, nelle Scogliere di marmo dice: «Non una casa vien
costruita, non un’architettura progettata, ove la ruina non sia
implicita, posta quale pietra di fondamento».
Anche Kipling, che pure
era un Libero Muratore, anzi proprio per questo, nel suo racconto The
Bridge-Builders mette in contrapposizione lo spirito della
tradizione Indù, ancora legata al rispetto dei limiti imposti
all’uomo dalla natura, alla presunzione tecnicista dell’ingegnere
britannico che, nel caso, darà la colpa del crollo ad un problema
legato ai materiali, non alla insipienza umana.
Sempre Kipling, Nell’Uomo
che volle farsi Re, fa emblematicamente condannare a morte il
supponente protagonista facendolo precipitare in un baratro dopo che
gli indigeni hanno tagliato le corde del ponte sospeso. Il ponte è
allora una metafora, non solo un’opera dell’ingegno umano; esso è
sì sospeso tra ciò che ci trasporta al di là della nostra
individualità, ma la sua caducità è anche la nostra; è questo il
binomio imprescindibile e necessario del quale dobbiamo essere
consapevoli per non incorrere nel peccato massimo che i Greci
attribuiscono all’umanità: l’hybris, la sfida arrogante ai
limiti imposti dalla natura e l’ottusità che la accompagna, ciò
che ha sempre causato i disastri più grandi.
Ecco che il crollo del
Ponte Morandi dovrebbe insegnarci molte cose, non solo sulla
eventuale carenza di manutenzione, sull’aumento esponenziale del
traffico o altre cause «tecniche» che verranno evidenziata
dall’inchiesta, ma una riflessione ben più profonda sul modello di
sviluppo che vogliamo perseguire, sul ritorno necessario ed
impellente al dialogo con le forze di un pianeta per il quale siamo
evidentemente un ospite sgradito, un hostis più che un hospis.
Forse, per concludere,
bastano a questo punto le parole che Leopardi scrive nell’ottobre
del 1821 nel suo Zibaldone: «L’uomo che a tutto si abitua, non si
abitua mai alla inazione. Il tempo che tutto alleggerisce,
indebolisce, distrugge, non distrugge mai né indebolisce il disgusto
e la fatica che l’uomo prova nel non far nulla».
E allora su questo tratto
dell’antropologia umana che bisogna riflettere prima di continuare
ad aggredire il Mondo: l’opera che stiamo per realizzare, il ponte,
la strada, l’ennesimo stadio o centro commerciale, è sostenibile
non solo dall’ambiente ma dalla nostra stessa coscienza? Possiamo
rispondere a questo interrogativo non più da soli, come già ci
dicevano gli antichi, ma tornando all’ascolto di quelle forze
naturali che oggi, drammaticamente, come il Grande dio Pan, si
svelano tremende quando, pur avendoci avvertito per anni, sono
rimante inascoltate.
Il Manifesto – 22 agosto 2018