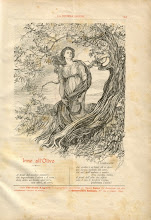domenica 27 febbraio 2011
Da vedere: Il cigno nero di Darren Aronofsky

Ricordate la ragazzina di “Léon” di Luc Besson? Oppure la regina Amidala di Star Wars? Natalie Portman è cresciuta e ci regala la sua miglior interpretazione di sempre, anche grazie alla regia di Darren Aronofsky. Dopo l'acclamatissimo “The Wrestler”, vincitore del Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia nel 2008, il regista americano indaga ancora una volta sul corpo come ‘luogo dell’anima’. Ma se in quello il corpo di un lottatore – Mickey Rourke – diveniva mezzo di rinascita e di riscatto morale, in questo il corpo della danzatrice diventa campo di ricerca della perfezione artistica.
Nina (Natalie Portman) frequenta una famosa scuola di ballo di New York diretta dal coreografo e regista Thomas Leroy, il sempre bravo Vincent Cassel. Quando Leroy la sceglierà per interpretare “Il lago dei cigni” di Caikovsky, licenziando la prima ballerina Beth Macyntire – una ritrovata Winona Ryder –, Nina dovrà mettercela tutta per interpretare al meglio sia la parte di Odette (il cigno bianco, incarnazione dell’amore puro), sia la rivale in amore Odile (il cigno nero). Nina eccellente nel primo ruolo, inizierà un processo di metamorfosi popolato di incubi e ossessioni per calarsi anche nell’antitetica figura del cigno nero che in qualche modo si invera nell’antagonista Lily – l'attrice Mila Kunis (piccola curiosità: è la doppiatrice di Meg de “I Griffin”) – con la quale instaura un rapporto di ambigua competizione mista a un’attrazione morbosa.
Lo si potrebbe definire il lato oscuro di Scarpette Rosse – il capolavoro di M. Powell (1948) –, la rappresentazione del male più nascosto che alberga in noi, un viaggio nelle distorsioni della psiche umana che costringerà la protagonista a gesti di autolesionismo e a vedere la sua immagine sdoppiarsi in quella che si rivelerà la sua peggior nemica, ovvero se stessa.
Candidato a cinque Oscar tra cui miglior film, miglior fotografia (superbo il lavoro di Matthew Libatique) e miglior attrice protagonista (la Portman, ricordiamo, ha già meritatamente vinto il Golden Globe per questo ruolo), anche se alla Mostra di Venezia ha diviso sia il pubblico che la critica, “Il cigno nero” coinvolge emotivamente lo spettatore in un vortice angoscioso dove non si comprende fino in fondo se quello a cui si sta assistendo sia realtà o frutto della mente. Una sorta di horror più cerebrale e visionario. Un film sicuramente da vedere.
Frase: "L'unico vero ostacolo al tuo successo sei tu: liberati da te stessa. Perditi, Nina".
http://a.marsala.it/rubriche/34-cinevisioni/28767-qil-cigno-neroq-di-darren-aronofsky.html
venerdì 25 febbraio 2011
Biamonti e Morlotti: l'immagine e la parola

Non ci si può accostare alla scrittura di Francesco Biamonti senza conoscere l'opera pittorica di Ennio Morlotti. Un caso pressochè unico di simbiosi fra parole e immagini.
Marco Grassano
L’immagine, la parola, il suono, il silenzio
L’accostamento e il raffronto che proponiamo tra un pittore e uno scrittore dalle comuni esperienze e dalle forti consonanze possono permetterci di comprendere meglio il lavoro di ambedue, ma anche – forse – di dare un’occhiata dietro le quinte che coprono l’eterno rapporto tra le arti figurative e quella verbale, tra il luogo dipinto e il luogo narrato, come recita il sottotitolo di questa iniziativa.
È certo che Morlotti e Biamonti si sono incontrati quando i loro universi culturali erano già definiti, e che sono state le sensibilità affini ad innescare la miccia di un’amicizia durata più di trent’anni, fino alla morte del pittore. Ma è del pari innegabile che la forza gravitazionale dell’uno ha prodotto effetti sugli sviluppi dell’altro, e viceversa. Aldilà della conferma reciproca delle rispettive scelte, l’opera di entrambi reca il segno di questo incontro: un segno visibile, un segno fatto di immagini, di colori, di percezione e di riproduzione del paesaggio.
Intendiamo però prendere in considerazione anche quanto osservava Vasilij Kandinskij circa “un’affinità fra le arti e in particolare fra musica e pittura: da questa singolare affinità è certamente nata l’idea di Goethe che la pittura debba avere il suo basso continuo” (Lo spirituale nell’arte, cap. VI). Avremo infatti modo di ascoltare l’esecuzione dell’ultimo movimento del Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen, “Louange à l'Immortalité de Jésus”, nel quale, come Biamonti disse magnificamente in una sua intervista del 1995 a Giorgio Ribaldo, “c'è questo affievolirsi del suono del violino e questa eco lontana del pianoforte, come se il divino, per immortalizzarsi, dovesse toccare le rive del silenzio”.
Nella stessa occasione, lo scrittore sambiagino aveva affermato: “La musica serve molto, o perlomeno modellarsi su alcune sue strutture: sapere dove si vuole andare a finire, come riprendere dopo un adagio, cosa ci può stare dopo un andante. Nella prosa è lo stesso: ci sono andanti e adagi. Io ne parlo un po' da incompetente, ma per scrivere ho bisogno di ascoltare musica perché mi sbarazza della grevità delle cose pratiche, facendo librare lo spirito e muovere l'anima”.
Anche Morlotti, per dipingere, ascoltava musica da un vecchio giradischi che teneva nel suo studio: “Guardi i miei dischi… Ascolto sempre gli stessi. Quando mi piace una cosa è difficile che cambi idea. Ascolti, ascolti questo pezzo di Schubert, mi piace quel piano. È un singhiozzo dell’anima” confidò nel 1992 a Caterina Bellati.
Biamonti selezionava le parole con una particolare attenzione al loro suono. Un esempio particolarmente significativo lo troviamo nelle poesie di Valéry che Francesco si era annotato lin-guisticamente per una migliore comprensione, ed in particolare nella prima strofa della poesia L’été (la relativa pagina era visibile in una esposizione a San Biagio, allestita per l’anniversario della scomparsa). Lo scrittore aveva segnato a margine la traduzione di alcune parole: “ruche” con “alveare”, “cruche” con “brocca”. Giunto però a “bourdonne”, la cui traduzione più ovvia sarebbe stata “ronza”, ecco che, tra le possibilità fornite dal dizionario Garzanti che di solito utilizzava, Biamonti ne ha scelta una suggestivamente sonora: “mormoreggia”. Sembra quasi una parola pascoliana, fa venire in mente i celebri versi del Gelsomino notturno: “Un’ape tardiva sussurra / trovando già prese le celle”. Franco Contorbia ha acutamente rilevato l’importanza di Pascoli per la formazione del linguaggio biamontiano, ed ha pure sottolineato la parentela tra la critica d’arte di Biamonti e quella di Francesco Arcangeli: il quale aveva fatto riferimento, nell’introduzione del suo fondamentale libro su Giorgio Morandi, uscito nel 1964 (volume presente nella biblioteca biamon-tiana), allo “sviscerato amore per Pascoli” dei propri tredici anni. Ma anche Maurice Merleau-Ponty e la filosofia della percezione hanno contato molto nella scrittura biamontiana: si pensi, per esempio, a quanto la nota relativa a un quadro di bagnanti descritto in Le parole la notte – “la donna aveva delle macchie che sembravano sanguinare” – debba alla seguente considerazione del pensatore francese: “Gli oggetti della pittura moderna sanguinano, spargono sotto i nostri occhi la loro sostan-za” (La prose du monde).
Sempre nell’intervista a Ribaudo del 1995, Biamonti affermava: “La parola è anche un po' corrosa, ma in definitiva dovrebbe imprigionare il silenzio, che poi è il canto delle Sirene. (…) La musica più grande, quella del canto delle Sirene, è il Silenzio. Ma come circoscrivere e far sentire il Silenzio? Anche qui è una sapienza della lingua: il reinventare una parola che ghermisca il silenzio che è al fondo dell'esistenza, della grande solitudine”. Affini a queste sono le riflessioni di Nicolas Bouvier, scrittore-viaggiatore ed “iconografo” ginevrino, nato nel 1929 (quindi praticamente coeta-neo di Francesco) e scomparso all’inizio del 1998. Bouvier, in frasi nelle quali possiamo riconoscere una interessante consonanza col linguaggio biamontiano, lamenta la difficoltà ad esprimere con parole logore, deformate dall’uso, il senso delle cose. Se ci si prova, si raggiunge presto quella che lui chiama “una dogana di silenzio. Chi si avvicina a questa dogana vi rischia la ragione, il suo linguaggio si scarnifica, si sbianca, si ossifica, come un lenzuolo d’ospedale o uno scheletro. Se questa dogana è superata, tutto precipita nell’opaco, nell’innominabile, nel bianco: non c’è più testo, non ci sono più nomi”. Ecco che allora ci soccorre il potere espressivo primordiale della musica: “una vita senza musica non ha molto senso” conclude (L’Échappée belle, testo pubblicato postumo, nel 2000).

de Stael, Concerto (1955)
Al silenzio sembra accostarsi anche l’ultimo quadro, rimasto incompiuto, di un altro Nicolas, De Staël: Il concerto. Da un lato dell’ampia tela (3,50 x 6 m) c’è un pianoforte, dall’altro un contrabbasso, in mezzo dei leggii e degli spartiti: ma non c’è la musica, perché essa ha bisogno, per sussistere, di qualcuno che la esegua (non prendo qui in considerazione la teoria, cara a certo decadentismo – la si trova, per esempio, in A ritroso, di Huysmans –, secondo la quale la migliore frui-zione di un’opera la si ottiene leggendone in aristocratica solitudine la partitura), mentre nel dipinto si apprezza solo la vibrazione dei colori in uno spazio dal quale ogni presenza umana è bandita.
Biamonti, fino al 1959, aveva composto qualche breve testo narrativo, ottenendo una certa notorietà nel mondo culturale bordigotto. Fruiva ed amava la pittura, ma non ne aveva mai scritto. È probabile (ed anche il bel ricordo di Nico Orengo in catalogo mi invita a pensarlo) che il discuterne appassionatamente con Morlotti lo abbia indotto ad affrontare il tema anche sulla pagina, con la for-za e la finezza che possiamo apprezzare nei suoi testi di critica d’arte e con un lessico di chiara a-scendenza ligure (Montale, Sbarbaro, ma anche Boine).
Morlotti, d’altronde, veniva guidato dall’amico “indigeno” in lunghe escursioni tra gli aspri e dolcissimi paesaggi dell’estremo ponente ligure, che lo avevano colpito, fin dal suo arrivo, per l’intensità della luce e la vivezza dei colori – la stessa “suggestione meridionale” che, per esempio, la Provenza esercitò sugli impressionisti. La Liguria diventava così, per lui, un paesaggio dell’anima su cui misurare gli altri paesaggi reali, come è avvenuto anche per Lalla Romano che, nel Diario di Grecia, finisce per vedere nelle rive elleniche “una specie di Liguria”, secondo quanto Biamonti stesso mi fece notare nel 1998.
Il poeta e critico francese Yves Bonnefoy, all’inizio del suo denso saggio sulla funzione dell’arte intitolato Lo sguardo e gli occhi, cita un celebre passo del volume proustiano La prigionie-ra, quinta stazione della Recherche: “L’unico vero viaggio, l’unico bagno di giovinezza sarebbe (…) avere altri occhi, vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri, vedere i cento universi che ciascuno di essi vede, che ciascuno di essi è”. Ecco, allora, che Biamonti fornisce a Morlotti “occhi nuovi” con cui vedere (e dipingere) la Liguria, e Morlotti fornisce alla memoria di Biamonti luoghi dipinti (ossia selezioni compositive dei luoghi reali “visti con occhi nuovi”) che ne sostanziano la prosa. Gli uliveti aggrappati ai pendii “come farfalle dalle ali polverose” di cui scrive Francesco sono quelli, materici, di Morlotti; analogamente, hanno provenienza pittorica le pietre vellutate dei roccioni, la luce ruvida nel cielo, il “fragile amalgama” di un insetto posato su un fiore… L’approccio di scrittura (o di descrizione) viene trasferito dai dipinti su cui la penna critica di Biamonti si sofferma ai paesaggi che ne popolano i romanzi, con effetti di trasparenza emotiva, di tensione e suggestione cromatica veramente sontuosi, come lo è il viola che il tramonto di inizio dicembre spalma, da quelle parti, sui pendii e sui crinali (e che si può osservare in alcune delle opere esposte, compresa quella scelta per l’invito all’appuntamento odierno. Curiosamente, troviamo una tonalità analoga nella descrizione che Claudio Magris ci dà di un tramonto sulla pampa argentina: “Scende la sera, in cielo si rompe una fiasca di vino e si spande dappertutto”, Un altro mare).
Di brani in cui Francesco, per dirla con Paolo Zublena, “scompone e ritrae in parole il paesaggio con l’occhio del pittore”, effettuando una vera e propria “verbalizzazione dello sguardo”, se ne trovano in ogni sua pagina. Zublena stesso ne dà un elenco più che rappresentativo nel suo saggio del 2002 Lo sguardo malinconico sullo spazio-evento. Biamonti, Morlotti e il paesaggio dipinto.
Morlotti, Paesaggio (1964)
Non dispongo di elementi sufficienti a stabilire se e quanto Biamonti e Morlotti conoscessero le opere dei due grandi poeti greci del ‘900, Yorgos Seferis (Nobel 1963) e Odisseas Elitis (Nobel 1979), che pure hanno dedicato una particolare attenzione di scrittura al paesaggio della loro terra (mi sembrano specialmente significativi i seguenti versi di Elitis: “e molti ulivi / che setaccino nelle loro mani la luce / e leggera essa si stenda sul tuo sonno / e molte le cicale / che non sentirai più / come non senti più il battito del polso”. Pare quasi di vedere i rami contorti come dita nocchiute e la mobile penombra luminosa che anima gli uliveti nelle giornate di vento, e si avverte come in un’eco del ricordo il canto compatto di migliaia di cicale, così uniforme e costante da diventare inavvertito. Elitis aveva tradotto in greco i surrealisti, da Eluard a Lorca - e qui Francesco citerebbe: “ricordo una brezza triste fra gli ulivi” -, ma a me vengono in mente anche le cicale virgiliane che, con la loro voce querula, “rompono gli arbusti”: attorno a questo verso delle Georgiche, Carducci ha costruito una delle pagine più belle della sua prosa). Testimoniano tuttavia un forte interesse le parole di Morlotti, ancora a Caterina Bellati (1992): “La Grecia. Per chi la ama è una grande passione. Ci sono andato appena dopo la guerra mondiale. Lì c’è la luce, quella che ogni pittore cerca. Hai un bel cercare lo studio con la luce giusta. Quella luce lì, c’è solo su quel mare, sotto quel cielo”. In questo Morlotti pare riprendere parzialmente De Staël, il quale aveva scritto della costa provenzale: “La luce è semplicemente folgorante, qui, molto più di quanto ricordassi”. E ancora: “Evidentemente è una grande lezione che dà questa luce greca dove solo la pietra e il marmo resistono in radiazione. A conti fatti, né Cézanne, né Van Gogh, né Bonnard se ne sono serviti altrimenti che da sperone psichico, voglio dire sul piano intimo: avrebbero potuto dipingere ciò che hanno dipinto veramente non importa dove; i greci no, è totale, la loro scultura prende e rende questo sole come è impossibile fare altrove: in tutta la sua semplicità”.
Forse i nostri due artisti hanno ritrovato, passeggiando, le onde cromatiche, le piccole lance metalliche orlate di ombre scure degli ulivi vangoghiani (questi intrecci di ombre, in Morlotti, sono passati a listare di nero le curve dei fichi d’India, che lui ha voluto chiamare, esoticamente, “cactus”).
Gli ulivi sono sempre stati piante fruttuose di riscontri nell’immaginario poetico. Narra la leggenda che la capitale della Grecia abbia preso il nome dalla dea Atena, la quale aveva donato agli uomini l’ulivo (ed era stata, per questo, preferita a Poseidone, che aveva offerto invece il cavallo). Il barocco spagnolo Alonso de Salas Barbadillo, nel suo Viaggio di saggezza (che qui riportiamo vestito delle poderose parole italiane di Carlo Emilio Gadda), annota: “Degnatevi di volger gli occhi all’uliva, a questo essere così laborioso e paziente! (…) La sua fronda perenne è una continua promessa, una vivente speranza per i cuori degli uomini: è dessa l’insegna della pace, a domandarla e a riceverla. (…) Consideratene le facoltà, l’onnipresente valore. Contro uggia e tristezza, un verde allegro e festante, giocondo ammanto dei colli e della riviera. Allegro, e quel che conta, perenne. Contro necessità e fame, un prezioso alimento. Contro le cieche tenebre dell’ignoranza, lume e splendore”.
Ma anche quest’albero così vetusto, simbolo della mediterraneità fin dai tempi degli dèi cto-nii, ha trovato “occhi nuovi” per guardarlo, una nuova sensibilità percettiva che dagli impressionisti, passando attraverso la “linea ligure” della poesia e della pittura (quanti dei suoi verdi-grigi-azzurri vibranti si ritrovano, per esempio – e devo il suggerimento a Dino Molinari -, anche in un pittore apparentemente avulso dal figurativo come Gian Franco Fasce!), si prolunga fino ai nostri giorni. Così l’architetto paesaggista, e raffinatissimo prosatore, Paolo Pejrone ha potuto scrivere, su Tutto-libri di sabato 4 dicembre 2004: “Vivaci ed argentei, gli ulivi, invece, continuano tranquilli il loro tragitto sapiente di ospiti amati in un posto difficile: le loro foglie d’argento sono un colpo di colore gioioso alla luce dei raggi di un sole ancora forte. Sotto le raffiche di un vento modesto e locale, vivaci ed eleganti, si muovono: che cosa c’è di più bello e prezioso?”.
In Morlotti, gli ulivi, le rocce ma anche i cactus si pongono contro il cielo quasi a formare una barriera, un muro (“Lo spazio pittorico è un muro, ma tutti gli uccelli del mondo vi volano libe-ramente, a tutte le profondità” osservò De Staël del proprio dipinto I gabbiani, che Biamonti scelse per la copertina di Vento largo). Queste barriere, come la siepe leopardiana, paiono suggerire alla mente che c’è un oltre, un aldilà spaziale al quale si può giungere attraversando il blu intenso di quel cielo.
Lasciamoci cogliere dalle ampie e acute suggestioni dischiuse nelle ricche immagini di Morlotti e nelle dense parole di Biamonti. Su entrambi, gli interventi che ascolteremo ci offriranno sicuramente illuminazioni nuove.
(Introduzione alla giornata di studio su Francesco Biamonti, Alessandria 31 gennaio 2005)
mercoledì 23 febbraio 2011
... e donna sia ! Carla Rossi a Villa Groppallo
carlarossi a villa groppallo
7 – 17 marzo 2011
inaugurazione sabato 7 marzo, ore 17
centro policulturale di villa groppallo - via aurelia 72 - vado ligure (sv) – tel. 019.883914
Isidore Isou: avanguardia e metodo

Sandro Ricaldone
Isidore Isou: avanguardia e metodo
A sessant’anni di distanza dagli esordi, uno sguardo retrospettivo sull’avventura di Isidore Isou e del movimento lettrista mostra, insieme, la precoce definizione di un progetto di ampio respiro, non limitato all’ambito artistico, e la costanza degli sviluppi articolati nel tempo.
E’ infatti agli anni dell’adolescenza - vissuta in Romania durante il secondo conflitto mondiale, sotto il regime filonazista del generale Antonescu, in un contesto reso particolarmente incerto dalle origini ebraiche dell’autore e dalla sua frequentazione di gruppi sionistici legati alla Resistenza - che va ricondotta l’individuazione della “lettera” come elemento base del rinnovamento creativo in campo della produzione lirica (cui presto s’aggiungeranno gli ambiti musicale e plastico) ed il primo manifesto di una poesia ancora a venire. Ciò che distingue, da subito, l’approccio di Isou dagli azzardi delle avanguardie primonovecentesche, futuriste e dadaiste, con cui condivide la radicale contrapposizione alle forme acquisite e ormai prive di un dinamismo interno e la tecnica dello scandalo programmato (2), è la sistematicità dell’analisi su cui si fonda, nella quale s’intravede il primo nucleo della elaborazione di una metodica generale della creazione che troverà il suo compimento ne “La Créatique ou la Novatique” (3), compendio di un processo di riflessione esteso dal 1941 al 1976 ed oltre.
Come testimonia il suo primo volume, pubblicato nel 1947 da Gallimard, “Introduction à une nouvelle poèsie et à une nouvelle musique”, Isou muove infatti da una ricognizione a vasto raggio degli svolgimenti della poesia universale – il prototipo di quella che chiamerà la carte de l’acquis – nella quale distingue una fase “amplique” (d’ampiezza), che dall’epica delle origini si protrae sino al primo ‘800 attraverso “opere immense” di soggetto narrativo o aneddotico, da una fase “ciselante” (di cesello), inaugurata da Baudelaire e variamente sviluppata da Verlaine e Rimbaud nel senso di una progressiva concentrazione sul poema, sul verso e sulla parola (elevata da Mallarmé al più alto livello di tensione espressiva), che prelude all’isolamento della lettera (4), elemento inscindibile con la cui “liberazione” si conclude il lavoro di purificazione e distruzione e si schiude (o si dovrebbe dischiudere) una nuova dimensione d’ampiezza.
In questo senso – secondo quanto osserva Mario Costa nelle pagine de “Il ‘lettrismo’ di Isidore Isou” (5) – il progetto non avrà un seguito puntuale, laddove invece, negli anni immediatamente successivi, si riscontra un’inusitata estensione orizzontale del procedimento “ciselant”, applicato oltre che alla musica - accomunata alla poesia dall’elemento sonoro - alle arti visive, nel cui ambito la lettera assume il valore di segno e, quindi, al teatro, al cinema, all’economia, dove la decostruzione (la super-brisure nel lessico isouiano) dà luogo a numerose realizzazioni innovative.
In parallelo si viene frattanto delineando uno schema di super-aggregazione che porta a riunire in insiemi più complessi o di ordine superiore elementi in origine distinti come la totalità dei supporti, usuali e non, conglobati nella mecaestetica integrale (6) od i diversi alfabeti, i pittogrammi, le parole incrociate, i rebus, i fumetti inclusi nel romanzo metagrafico (7) (che fondendosi con il teatro e la quotidianità assume una proiezione “tridimensionale” prossima alle “situations construites” in seguito proposte da Debord) e quindi nell’iper-grafia, dominio di tutte le scritture esistenti o da inventare, che a sua volta si protende verso la dimensione dell’immaginario (8).

I. Isou, La télévision dechiquetée ou l'anti-crétinisme
Sicuramente le realizzazioni artistiche fanno di Isou uno dei protagonisti della seconda metà del '900: basti pensare, per ciò che attiene alla poesia, agli esiti di "Lances rompues pour la dame gothique" (1947), uno degli incunaboli della poesia fonetica, od agli approdi azzeranti delle "lettries blanches" (1958) e, quanto alle arti visive, alla provocazione rappresentata da una pagina di ordinarie annotazioni classificata come "Nouvel object plastique" (1944) od alla sequenza dei "Nombres" (1952), sonetti trasposti in elementi figurativi, senza dimenticare i più tardi "Commentaires sur Van Gogh" (1985), grande opera-commento attorno ad immagini riprodotte dal pittore olandese. Il suo primo film, il "Traité de bave et d'eternité" (1951), costituisce una pietra miliare nella sperimentazione cinematografica contemporanea, mentre nel "Débat sur le cinema" (1952), dibattito su un film da fare, inesistente, realizza uno dei meta-film più estremi e nella pièce teatrale "La marche des jongleurs", tocca - inscenando la dissezione di un cane morto - i limiti de "la science nouvelle de l'outrage: l'outragéologie".
Né si può dimenticare la riflessione sulla condizione giovanile, "esterna" al sistema di produzione e socialmente marginalizzata, riflessa a partire dal 1949 nei "Manifestes du soulevement de la jeunesse" (10) o le battaglie che oggi si direbbero di "liberazione della sessualità" e contro la repressione psichiatrica intraprese rispettivamente alle soglie degli anni '50 e '70 (11)
In prospettiva, però, l'obiettivo che Isou sembra essersi posto e che emerge con chiarezza sin dalla giovanile autobiografia, "L'agrégation d'un Nome et d'un Messie" (12), quello di divenire il Nom des Noms, l'artista degli artisti, colui che è chiamato a sostituire la Creazione al primato cartesiano della Ragione, risiede principalmente in quello che possiamo considerare il suo (fluviale) "discorso sul metodo". Un metodo infinitamente complesso, che integra - accanto alle componenti citate - l'iper-variazione, l'iper-delimitazione, l'iper-multi-morte di tutte le branche culturali, l'iper-classificazione, la super-esperienza, l'iper-teologia …, ma che si è dimostrato, nel tempo, un effettivo moltiplicatore di sapere e di esperienze inedite, una disciplina capace di innalzare l'arte ad un nuovo, diverso livello, dal dominio delle forme al campo delle idee che le organizzano.
Note:
1) “E’ stato nel leggere Kaiserling (sic) che ho avuto l’idea di una poesia basata sulle lettere. L’autore diceva che i poeti utilizzano dei vocaboli (vocables, nel testo francese). Vocables in rumeno vuol dire “vocali”, e questo mi ha dato l’idea della “poèsie à lettres”. Ne ho subito preso nota nel mio diario, sotto la data del 19 marzo 1942”. (V. Frederique Devaux, “Entretiens avec Isidore Isou”, La Bartavelle Editeur, Carlieu 1992, pag. 47).
2) Fra i più noti la manifestazione svoltasi il 21 gennaio 1946 al Théâtre du Vieux Colombier dove ad una rappresentazione de "La Fuite" di Tristan Tzara, mentre Michel Leiris sta pronunciando un breve intervento sul Dadaismo, viene interrotto da un gruppo di lettristi che reclamano la parola. Al termine della rappresentazione Isou improvvisa un discorso sui fondamenti del Lettrismo e legge alcuni poemi composti di consonanti e di vocali pure. "Combat" titola: "I lettristi mettono in fuga Tzara".
3)Isidore Isou, “La Créatique ou la Novatique (1941-1976)”, éditions Al Dante – Léo Scheer, Romansville 2003.
4) Secondo Isou nè Dada nè il Surrealismo pervengono a questo risultato. Tzara infatti si limita ad attaccare “ciò che ancora rimane di logico e di sensato nella poesia”, facendone una “nozione vuota”, analogamente a ciò che farà poi Breton attraverso l’automatismo psichico.
5) Mario Costa, “Il ‘lettrismo’ di Isidore Isou”, Carucci editore, Roma 1980 (v. in particolare le pagg. 24 e seguenti).
6) Isidore Isou, “Esthétique du cinema” in “ION” (numero unico), 1952.
7) I primi esempi della specie sono “Les journaux des dieux” di Isou (Aux escaliers de Lausanne, 1950); “Saint-Ghetto-des-Prets” (Editions O.L.B., Grimoire, 1950) di Gabriel Pomerand e “Canailles” di Maurice Lemaître (“Ur” n. 1, 1950).
8) Isidore Isou, “Introduction à l’esthétique imaginaire”, in “Front de la Jeunesse” n. 7, 1956.
9) Isidore Isou, “Le manifeste de l'excoordisme et du téïsynisme” (1992) consultabile su “etweb, le site de l' excoordisme et du téïsynisme” (http://perso.wanadoo.fr/e.t.web/ index.html).
10) Isidore Isou, “Traité d’économia nucléaire. Le soulèvement de la jeunesse” tome I, Aux escaliers de Lausanne 1949 ; Id., “Les manifestes du Soulèvement de la jeunesse. 1950-1966”, Centre de Créativité, 1967.
11) Isidore Isou, “Isou ou la mecanique des femmes”, Aux escaliers de Lausanne, 1949 ; Isidore Isou, “Je vous apprendrai l’amour, suivi de Traité d’erotologie mathématique et infinitésimale”, Le terrain vague, 1959. Isidore Isou, “Manifeste pour une nouvelle psychopathologie et une nouvelle psycothérapie”, in “Lettrisme”, n. 18-22, 1971.
12) Isidore Isou, “L’agrégation d’un Nom et d’un Messie ”, Gallimard 1947
(Da: http://www.quatorze.org/isoucre.html )
martedì 22 febbraio 2011
Augusto Guido, un fisico dallo spirito classico
In occasione dell’inaugurazione della storica aula di fisica del Liceo Classico,
Interviene Giulio Manuzio, Dipartimento di Fisica, Università di Genova.
L’incontro prevede la visita alla collezione di strumenti di fisica del Liceo a cura di Carlo Ciceri, Liceo Classico Chiabrera.
Luna di Mele
ore 21:00
ci sarà lo spettacolo
LUNA e L'ALTRA TEATRO
di e con Francesca Varsori e Adriana Giacchetti
uno spettacolo che parla di donne, della quotidianità e della violenza con ironia, canto, poesia e orgoglio femminista.
Lo spettacolo è ad entrata libera ed alla fine saremo lieti di offrirvi un dolce ed un bicchiere di vino per chiaccherare delle emozioni e dei pensieri che lo spettacolo ci avrà stimolato e per incontrarci.
giovedì 17 febbraio 2011
Gli anni '60 e il nuovo teatro italiano: Carmelo Bene
Ciclo di incontri organizzato dalla Provincia di Genova in collaborazione con la Fondazione Novaro e il Museo dell'Attore
Mercoledì 23 febbraio 2011 - ore 17,00
mercoledì 16 febbraio 2011
Un mare fatto di silenzi. Poesie di Marcella Formisano

Non pennellerò la Tua avventura...
avrei potuto farlo ieri
laddove la sabbia smussava le
...periferie del tempo
Provato, stanco di accontentare e
resistere al Verbo in liquidazione...
traghetta con dolenza una civiltà ignota.
Ciò che il muscolo cardiaco ha fotografato
è...
intrappolato nella mente e...
a nulla giova navigare tra
materie e tessuti
...inorganici e qualunquisti
Piccole sfumature
Non prepongo alle facciate esposizioni
meglio bianche e libere come...
orchidee selvatiche
Coperture che talvolta appaiono plumbee...
ed anche quel vaso sul davanzale
con dentro i miei fiori preferiti e ricercati
non hanno più colore
Rivoglio la tv in bianco e nero
ed una serata trascorsa a leggere
un pò di me...
Prospettive in...''volo''
...hai ciecamente voltato le spalle al mare!
Forgia la scranna a prender morbide forme...
portala in volo con la tua intimità
lasciala sfiorare dal refolo salmastro fino ad
innalzarsi sulle onde del cielo
Compagnia teatrale
''La precarietà dell’esistenza”
timore Sovrano
in cui disperatamente poni rimedio!
La successione illimitata di fatti ed eventi
ti soffoca fino ad ostacolare circolazione al cervello
nonostante la tua fragile resistenza.
Esseri legati all’abitudine
intenti ad addestrare i vostri corpi e la vostra voce
strutturati in tristi e squallide situazioni “definite”
con accanto spesso...
…”Compagni di solitudine”!
Altalena
Rivoglio quel profumo di
corda e ruggine tra le mani e
leccarne le ferite.
Anelli aggiunti e spezzoni di funi
annodate...logorate da
quel vento salmastro
in questo sfondo di cielo che
sembra non essere più il mio
Orme sulla sabbia bagnata e...
un'altalena che non si potrà fissare!
Odori
Questa percezione di celia nirvana
palpita nell'aria
imprigionando emozioni intinte nel miele
oltre la luna
spogliata dalle nuvole
mentre colori svariati si mescolano
per dare vita ad un perfetto mosaico
che fanno da contorno a questa ''strana festa'' e...
sorridi sotto la pioggia di jazz e blues
Non hai paura di perderti
varcando confini immaginari
ove ti dissolvi in quel mare fatto di
silenzi
leccando note dell'essere
assaggiando il pensiero di
...partire dal mondo
 Marcella Formisano è nata a Napoli, ma da anni risiede a Savona. Insegnante precaria dal 1982, attiva nel volontariato, si interessa di poesia, musica e pittura ed in genere di tutto ciò che ha a che fare con la creatività.
Marcella Formisano è nata a Napoli, ma da anni risiede a Savona. Insegnante precaria dal 1982, attiva nel volontariato, si interessa di poesia, musica e pittura ed in genere di tutto ciò che ha a che fare con la creatività. martedì 15 febbraio 2011
Da leggere: Ricomporre Ipazia

Maestra, scienziata, filosofa e politica nel difficile contesto di Alessandria d'Egitto tra il IV e il V secolo d.c., in una città letteralmente dilaniata dai conflitti etnici e religiosi, ai tempi della dominazione romana e delle cruenti lotte per la conquista del potere tra i gruppi esistenti di ebrei ed elleni e il cristianesimo delle prime espansioni, seppe imporsi con grande forza e autorevolezza in un mondo comunque dominato dagli uomini, una donna che scelse la libertà e la filosofia pagando con una morte esemplare ed atroce: forse per questo la Storia, scritta dai vincitori-uomini, l'ha rimossa e dimenticata.
Questa splendida figura dell'antichità, ci pone interrogativi e riflessioni innovativi oggi come allora, alla luce del nostro cammino di donne passate attraverso gli anni del femminismo e coscienti di vivere in un presente certamente contradditorio, ma ancora denso di fermenti mai sopiti, desiderose di far emergere i numerosi esempi di donne di valore, madri simboliche di tutte noi.
Parliamo di Ipazia come “Eredi biblioteca delle donne”: perché questo nome?
La biblioteca, simbolo e memoria della storia del femminismo a Savona è ritornata a vivere proprio l'8 marzo 2010, grazie all'ospitalità e all'opera di molte donne e insegnanti del Liceo Scientifico “ O. Grassi” di Savona.
L'eredità che abbiamo ricevuto e che siamo fiere di lasciare come testimonianza alle nuove generazioni è fatta di tante esperienze e riflessioni, di battaglie e di condivisione, ma anche di materiale documentario e librario che si era prodotto negli anni 70 e 80 quando si era formato anche a Savona un nucleo di donne che si rifacevano ad una politica delle donne differente e distinta rispetto alla tradizione emancipazionista dei movimenti femminili di ispirazione liberal-democratica e di sinistra.
Su questa linea di riferimento e sulla scia di riflessioni rispetto al femminismo oggi, ci siamo lasciate subito coinvolgere dal film “Agorà” del regista Amenàbar, recentemente uscito in Italia, che presenta la figura di Ipazia nell'agorà del suo tempo.
Il film, piacevole e abbastanza corretto dal punto di vista della ricostruzione storica, in realtà non pone al centro del discorso la figura della grande filosofa, che pure emerge e domina la scena con la forza della sua autorità, lasciando sullo sfondo il clima di oppressione e intolleranza che la circonda, infatti non affronta fino in fondo i nodi profondi che la storia di Ipazia solleva.
L'uscita del film ha suscitato discussioni e dibattiti sui media e nei contesti culturali, ma in genere è stato approfondito più l'aspetto delle lotte tra poteri politici e religiosi e poco quello della donna così autorevole nella cultura del tempo, in quel mondo patriarcale nel quale ella si muoveva con grande agio .
Ciò è successo anche al Filmstudio di Savona che ha proposto un dibattito molto partecipato e intellettualmente onesto, centrato quasi interamente sul contesto storico del momento e decisamente tutto al maschile.
Abbiamo così pensato di organizzare una serata di approfondimento e dibattito pubblico che fosse al tempo stesso motivo di crescita culturale per noi, ma anche momento politico di apertura all'esterno: una sfida per questi tempi di riflusso, spettacolarizzazione della politica e della cultura e frenetica evasione dalla riflessione critica.
Siamo state stimolate, anche grazie all'interesse e alla disponibilità di Giuliano Arnaldi, a cui va il nostro sentito ringraziamento, che con il MAP (Museo Arti Primarie) si occupa di arti a tutto campo ed è particolarmente sensibile ai temi del ruolo e della visione della donna nelle società primarie: importante è stato il suo contributo nella riuscita della serata.
La nostra visuale nell'approfondimento dell'argomento è quello della differenza sessuale, abbiamo infatti scelto di analizzare, attraverso le scene del film, la donna Ipazia, nelle sue vesti di Maestra, Astronoma e Scienziata, Filosofa e Politica libera e autorevole in tutti i luoghi pubblici, normalmente riservati agli uomini, così come ce la descrivono le fonti dell'epoca, da noi riprese dal libro fondamentale di Gemma Beretta studiosa e filosofa vicina alla “Libreria delle donne” di Milano, “Ipazia d'Alessandria” .
Il lavoro, frutto di elaborazioni comuni, riflette sia l'iter preparatorio, fatto di incontri, letture, visioni del film e discussione sulle scene da evidenziare, sia il pensiero delle relazioni vere e proprie presentate durante la serata.
Il testo presenta, tra un capitolo e l'altro, la breve descrizione delle scene del film che ci sono sembrate significative rispetto ai temi da noi approfonditi: in alcuni casi abbiamo evidenziato le differenze tra l'interpretazione del regista e le fonti storiche documentarie.
Nella stesura scritta poi, si è svolta un' ulteriore ricerca dei temi trattati e della bibliografia di riferimento, in modo da rendere più completo e ampio il lavoro.
Volutamente abbiamo scelto di lasciare il più fedele possibile il resoconto del dibattito al fine di dar conto e valutare il livello di ricezione del messaggio che si è voluto trasmettere.
Ci è sembrato importante, inoltre, lasciare traccia scritta del nostro lavoro affinché ne resti memoria per ulteriori approfondimenti e utilizzi in altri ambiti, anche in vista di progetti richiesti da insegnanti, da svolgere nelle scuole superiori di Savona.
Eredibibliotecadonne
domenica 13 febbraio 2011
Franco Astengo, Degrado morale e crisi politica

Franco Astengo
Nelle ultime ore pare avviarsi un precipitarsi della situazione politica: la nota del Presidente della Repubblica, circa il rischio di fine della legislatura, dovrebbe finalmente mettere in moto un meccanismo che ponga in discussione questo “iter”, insieme drammatico e grottesco, che sta percorrendo il Governo.
Contemporaneamente la manifestazione al teatro Dal Verme di Milano ( luogo scelto non a caso, dal punto di vista dei riferimenti storici) è apparsa emblematica del degrado morale, della vera e propria “dispersione etica”, che appare ormai essersi imposto nel confronto politico: una manifestazione non soltanto di “ultras” (il modello calcistico ormai ha fatto scuola) ma davvero dai toni e dai sapori “sansepolcristi”, del “me ne frego”, del mettersi sotto i piedi l'antiquato illuminismo della divisione dei poteri, per imporre il Capo ed il suo corpo, senza leggi, incarnazione del comando quale “unto del signore” (non a caso è stato evocato il '94: frontiere allora raggiunta e poi perduta).
La situazione ha ormai passato da tempo il limite del tollerabile, ed occorre una azione estremamente decisa, in Parlamento e nel Paese.
In Parlamento, nel Palazzo, nelle istituzioni va compiuto un passo importante da parte dei segretari dei partiti dell'opposizione (presenti o meno alla Camera e al Senato): la richiesta di un incontro comune con il Capo dello Stato dove segnalare con forza la gravità della situazione e ribadire l'indisponibilità di qualsiasi collaborazione parlamentare, e in altre sedi, con questo governo.
Nel caso in cui, poi, il GIP di Milano decidesse il rinvio a giudizio con rito immediato, credo sarebbe necessario un passo ulteriore: quello della richiesta di dimissioni immediate.
L'apertura della crisi lascerebbe poi la porta aperta a diverse soluzioni, ma è necessario recuperare anche su questo terreno l'iniziativa politica (ed il federalismo va bocciato, senza tentennamenti: è in gioco l'intera qualità della democrazia).
Sono previste, in queste ore, molte manifestazioni, la principale delle quali quella delle donne per domani 13 Febbraio: occorre lanciare un messaggio a tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti.
Non bisogna avere paura della politica, non bisogna parlare di “crisi della politica”: è in crisi “questa” politica, fatta di sopraffazione, di privazione di diritti, di inasprimento dello sfruttamento, di confusione con l'avanspettacolo di qualche tempo fa.
E' in crisi la politica che confonde la rappresentatività con il governo che diventa un “totem assoluto”, è in crisi la politica che mette il personalismo al primo posto , che si bea del “leader” e lo fa idolatrare da folle sempre più lontane, da un “popolo” indistinto; è in crisi la politica che non si misura con le questioni reali del concreto quotidiano ma semplicemente con l'audience degli spettacoli televisivi cui partecipano i suoi esponenti.
Mi fermo: forse scivolo in una sorta di populismo, ma è l'indignazione che mi fa scrivere e mi impedisce, una volta tanto, di articolare proposte compiute.
L'indignazione, però, è una componente essenziale della capacità di fare politica, politica per davvero.
 Franco Astengo, politogo e storico della sinistra, collabora con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova. E' autore di numerosissimi saggi apparsi su giornali e riviste.
Franco Astengo, politogo e storico della sinistra, collabora con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova. E' autore di numerosissimi saggi apparsi su giornali e riviste. sabato 12 febbraio 2011
Se non ora, quando?

Se non ora, quando?
Tante sono impegnate nella vita pubblica, in tutti i partiti, nei sindacati, nelle imprese, nelle associazioni e nel volontariato allo scopo di rendere più civile, più ricca e accogliente la società in cui vivono. Hanno considerazione e rispetto di sé, della libertà e della dignità femminile ottenute con il contributo di tante generazioni di donne che - va ricordato nel 150esimo dell’unità d’Italia - hanno costruito la nazione democratica.
Questa ricca e varia esperienza di vita è cancellata dalla ripetuta, indecente, ostentata rappresentazione delle donne come nudo oggetto di scambio sessuale, offerta da giornali, televisioni, pubblicità. E ciò non è più tollerabile.
Una cultura diffusa propone alle giovani generazioni di raggiungere mete scintillanti e facili guadagni offrendo bellezza e intelligenza al potente di turno, disposto a sua volta a scambiarle con risorse e ruoli pubblici.
Questa mentalità e i comportamenti che ne derivano stanno inquinando la convivenza sociale e l’immagine in cui dovrebbe rispecchiarsi la coscienza civile, etica e religiosa della nazione.
Così, senza quasi rendercene conto, abbiamo superato la soglia della decenza.
Il modello di relazione tra donne e uomini, ostentato da una delle massime cariche dello Stato, incide profondamente negli stili di vita e nella cultura nazionale, legittimando comportamenti lesivi della dignità delle donne e delle istituzioni.
Chi vuole continuare a tacere, sostenere, giustificare, ridurre a vicende private il presente stato di cose, lo faccia assumendosene la pesante responsabilità, anche di fronte alla comunità internazionale.
Noi chiediamo a tutte le donne, senza alcuna distinzione, di difendere il valore della loro, della nostra dignità e diciamo agli uomini: se non ora, quando? è il tempo di dimostrare amicizia verso le donne.
L’APPUNTAMENTO E’ PER IL 13 FEBBRAIO IN OGNI GRANDE CITTA’ ITALIANA
Susanna Camusso (Segretario Generale CGIL)
"Ho passato la vita a combattere contro chi voleva le donne sottomesse, subordinate, ubbidienti. Ho lottato per la mia libertà e quella delle mie compagne, per la possibilità di scegliere cosa essere e cosa diventare.
Vedo adesso come la declinazione principale di questa libertà, alla quale ho dedicato le battaglie più appassionate, sia torta in una versione brutale e bugiarda. E’ una libertà bugiarda quella che produce l’adesione ad un unico modello di femminile, costruito e pensato da uomini che non sembrano amare le donne, sembrano piuttosto amare sé stessi e tutto ciò che solletica e ratifica il loro dominio.
E’ una libertà mercantile, che si vende e che si compra, che contempla l’apparire, mai l’essere. In questa falsa arena delle libertà vincono i messaggi più ruffiani, quelli gridati con la voce più alta, quelli diffusi attraverso potenti mezzi di comunicazione, e la libertà vera, quella di scegliere criticamente cosa fare di sé e della propria vita, evapora.
Il riflesso di corpi femminili onnipresenti sui media, perfetti e patinati, sempre inesorabilmente con funzione ornamentale è una violenza rivolta alle donne, soprattutto alle ragazze più giovani. Una rappresentazione così distorta del femminile comprime la libertà di determinare il proprio modo di essere donna, di interpretare il proprio ruolo nel mondo e reinventare, per esempio, l’impegno civile e la gestione del potere.
Il 13 Febbraio, in piazza, ci ribelliamo a questa nuova dittatura del machismo, raccontando chi sono e come sono le donne vere. Né brave, né cattive. Semplicemente vere".
Raffaella R. Ferré (scrittrice)
Il tredici febbraio io...
Mi sveglio, mi pettino e allo specchio mi trucco. Vado veloce e mi porto avanti coi compiti della giornata, il tredici febbraio è domenica ma io lavoro lo stesso: le mie precarie occupazioni non conoscono giorni di festa; faccende e responsabilità ataviche che mi obbligano a mettere in tavola laboriosi piatti ne sanno ancora meno. La mia flessibilità, l'autonomia, esiste solo nei salotti televisivi: il tredici febbraio io che raccolgo i capelli e trucco gli occhi sono una donna che assolve alla sua prima mansione, io non stacco mai, sempre pronta, sempre duttile e disponibile, sempre carina, sempre attenta.
In questo giorno che cade e divide a metà il mese più corto, nel mio Paese 150 anni fa unito e tanto frammezzato e diviso sformato io sono una madre e una lavoratrice in cassaintegrazione, una scrittrice e un'impiegata. Sono, nell'ordine, una commessa e una ricercatrice, una femminista e del femminismo non so niente. Sono una minorenne marocchina e una precaria recidiva, io sono un'universitaria e una casalinga, e mi prendo tempo, lascio la spesa a metà, afferro la borsa.
Il tredici febbraio io porto per strada la mia rabbia come un cane senza guinzaglio, non giudico, non appartengo ad un partito o all'altro e non tollero: non sono agnello tra i lupi, né lupo travestito da agnello, non mi sottometto né agito la mia sottomissione come una spada. Il tredici febbraio io rinuncio alle file di denti da far brillare, al corpo teso da offrire come tangente, al piatto di pasta che mi faccia perdonare, sciopero anche la mia tranquilla forza lavoro pagata poco e male, smetto persino di sentirmi sprecata e costretta nell'angolo di una dicotomia che mi vuole pentita prostituta siliconata o grezza vergine slavata ma sempre femmina, sempre io, in fondo.
Il tredici febbraio io mi dimetto, mi licenzio. E al ruolo di efficiente, silenziosa, furba bellezza da pubblicità, io abdico. Il tredici febbraio io scendo in piazza.
venerdì 11 febbraio 2011
Per un'energia pulita: No alla Centrale a carbone!

Riceviamo e volentieri diffondiamo l'invito a partecipare alla manifestazione, indetta dall'Associazione Uniti per la Salute, per approfondire le conoscenze sui danni provocati dalla combustione del carbone e sulle possibili alternative per produrre energia in maniera meno aggressiva per la nostra salute.
giovedì 10 febbraio 2011
Storia di Adelasia e di Aleramo


Ma la damigella pur gli faceva assai festa, tanto che al fine non sapeva Aleramo che fare nè che dire. ... Tuttavia la fanciulla tanto seppe dire e fare, che Aleramo, disperando per una parte che l’imperatore si contentasse mai del loro amore, e dubitando per un’altra che durando ancora la cosa non si potesse più oltre celare, una notte menò via la fanciulla. E si vestirono per non essere riconosciuti, di abiti strani, e diversi; e su due cavalli, uno bianco e uno rosso fuggirono per foreste e per luoghi selvaggi. Alcuna volta si imbatterono nelle genti che l’imperatore aveva mandato a inseguirli; e quelli gli domandavano se sapessero novella d’un cavaliere di tali fattezze e in tale abito che menava con sè una damigella.

Mario Maria Martini: letteratura e politica attraverso le riviste

Prosegue la serie di incontri del ciclo Dalla “Riviera Ligure” al “Barco”, organizzato dalla Fondazione Novaro in collaborazione con il Teatro Stabile di Genova.
Venerdì 11 febbraio 2011, alle ore 17.30, nel Foyer del Teatro della Corte, per il terzo incontro, Stefano Giordanelli parlerà sul tema “Mario Maria Martini: letteratura e politica attraverso le riviste”. La conferenza sarà accompagnata dalla proiezione di immagini.
* * *
Il ciclo di incontri è volto a valorizzare aspetti poco noti, o dimenticati, della cultura in Liguria. Fondamentale risulta l’apporto che le riviste letterarie e non solo, ideate nella nostra regione nella prima metà del Novecento, hanno dato allo scambio e alla diffusione di movimenti, sperimentazioni, avanguardie, in Italia e anche in altri Paesi.
Se il quindicinale “Vita nova” (1902-1904) rappresenta ancora una cultura “fin de siècle”, Martini, ideatore e direttore de “La Rassegna Latina” (1907-1908, famosa soprattutto per le collaborazioni di Gozzano) non si sposta di molto da una letteratura tradizionale.
“Le opere e i Giorni”, una rivista pluridisciplinare (dalla letteratura alla politica, dalla scienza alle arti alla musica), sempre diretta da Martini dal 1922 al ’38, viene definito il periodico più rappresentativo del Ventennio a Genova, soprattutto in campo letterario.
Stefano Giordanelli ripercorre la storia delle tre riviste, considerando i differenti contesti in cui sono nate, le finalità, la redazione e i collaboratori.

mercoledì 9 febbraio 2011
Sus la traça di records/Sulla scia dei ricordi

più, diventa richiamo irresistibile per chi è nato in quelle valli; dove una “quioco” si scrolla di dosso il silenzio dove l“aiguio” ci porta con sé ad altezze vertiginose per abbracciare nell’insieme tutte le bellezze della Val Maira e far dimenticare la fatica delle giornate, le baite abbandonate, la solitudine. Le immagini di Roberto Beltramo allora intervengono, con la loro bellezza, a scrivere in un linguaggio compreso da tutti la poesia della luce e delle piccole cose che scende diretta dagli occhi al cuore: le camicine bianche appese ad asciugare davanti al camino, l’affondare del corpo nel profumo dei prati in fiore, il limpido riflesso dei ghiacci e il gioco delle nuvole in alto dove gridano le aquile, ma anche l’indicibile gelo delle sedie vuote e il lavoro dei “caviè” cristallizzato nella cera di un museo. Due tracce di poesia dunque, diverse ma preziose entrambe, per questo bisogno di agganciare la nostra vita a quella della nostra terra e dei nostri predecessori: passo dopo passo, seguiamo la scia dei ricordi! E per chi, troppo giovane, non ha costruito ricordi comuni, questa mostra è un bel momento di emozioni, un ritrovare anche solo un frammento di dialogo rimasto lì dall’infanzia, un invito a conservare e trasmettere le proprie radici, il patrimonio linguistico, la bellezza del territorio”.

La poesia come dissoluzione della parola nel movimento: Performate di Alberto Mori

Maria Grazia Martina
Action Poetry
Performate visualizza nel verso il movimento.
Il movimento che muove attraverso lo sguardo, repentino pensiero, verso la parola, soglia dell’approdo poetico.
Performate frammenta il tempo, come il diaframma apre all’ombra del pensiero nascente verso il punto focale del percetto poetico.
Performate dissolve nella parola la caotica molteplicità del reale, traslata dall’evocazione alla misura.
Performate libera dalla forma verbale per costruire il flash visivo.
Performate introduce al paradosso: definisce senza definire.
Performate analizza l’apparenza, il flash, nella s-definizione della parola.
De-forma nell’obiettivo concettuale ciò che dallo sguardo passa al pensiero.
Le 34 composizioni di Performate compiono e fanno compiere al lettore un movimento, un’azione verbo-temporale simultanea e fulminea, flash-sequenza.
Alberto Mori impagina parole in mappe verbali geometriche, concentra e incentra ritmiche percezioni in azioni poetiche, egli compie un gioco di meccanica della scrittura. La scrittura, per così dire, auto riflette se stessa attraverso l’atto proprio dello scrivere. In altre parole, In un riflesso di pluri direzioni, il poeta registra automatico il gesto poetico:
“Prensione della parola/Fiato alle mani/Lettere leccate fra la bocca tra le dita”
Auto-performa se stesso nell’attimo intuitivo, evocativo, comprensivo nel “fare” poesia.
Il poeta attua in questa raccolta traiettorie di senso per i sensi.
All’ascolto: atonali-scricchi-rumore-risuona-ritmica;
alla visualizzazione: Inizia la lettura degli occhi-fiamma-dissolvenza-bagliori-avvampano-illuminate;
al tatto: trasparenza-spessore-tra le dita- Aprendo il giornale dal fondo;
all’olfatto: nucleo d’aria-a soffio- fiato nelle mani;
al gusto: lettere leccate.
Egli ricorre, inoltre, a strutture compositive chiastiche:
all’antitesi: disciolto-ordinato-frenesia-modulare-oltranza-arresto;
al movimento: rotazione-torsione-attrae-rilascio-ferma-slitta-immobile-passo-evasione;
alla misurazione: azzera-perimetro-mappa-cifre-rettangolo;
al tempo: sfogliando all’indietro-istanti numerali-avvicendano-sparizione-mentre;
al ricordo: cielo memore del giorno-intrecci visionari-led sillabici- parola palindroma- fotogrammi cromati.
Performate inscena la composizione, non ne correla l’oggettivo, è tratto vivente dell’esperienza sguardo/gesto/parola/piano spaziotemporale del compimento sensoriale e concettuale nell’essenzialità del dire.
Il poeta non indugia, risolve nell’immediatezza sincronica dalla “lettura degli occhi” al “piano” della pagina, laddove la gestualità de-struttura e ri-compone il senso organico del verso.
Non c’è inizio e fine, ma continuità di frangenti sincronie di pensieri visualizzati nella parola, cinetica, complessiva.
Qui il poeta restituisce la dinamica corpo/mente nell’azione poetica, proietta sul piano-pagina un disegno che “ritrae” il tempo dall’ evocazione al suo avanzamento nello sguardo.
Infine, il suo dispiegarsi parola.
Azione trascrivente, ritmica ripresa del ciak all’infinito, sincopato nel respiro, nella pausa, nella posa.
Ancor più, rispetto alle precedenti raccolte, la sperimentale ricerca di Alberto Mori è per-formata nella parola, in transito tra sintesi e impermanenza.
Termini che rimangono percorsi privilegiati della sua traccia compositiva, ricercata nell’ambigua relazione tra ispirazione emotiva e meccanica della scrittura, metafora poetica.
Da "Performate"
Gesti irrelati da scoprire
vengono indossati dai corpi
Si immettono in avatar silenziosi
***
Rotazione
Accentro slitta
Allora il piano ravvicina le braccia
Ferma
Inizia la lettura degli occhi
***
Intanto la fiamma invisibile
avanza dalla dissolvenza dell'acqua
muore nella mano di terra
***
Un reattangolo d'asfalto
Maculi bianchi contrastativi al nero umido
L'immagine nel tempo
scivolamento dell'acqua versata
l'aria rasciuga con rumore di fondo
***
Nei cenni
Ora all'uno
Ora all'altra
Affacciati dagli sguardi
Mentre la carne passa
L'autore
 Alberto Mori, poeta performer e artista, in più di vent’anni di attività ha costruito e alimentato una personale attività di ricerca nella poesia, utilizzando di volta in volta altre forme d’arte e di comunicazione, dalla prosa alla performance, dall’installazione, al video e alla fotografia. Nello stesso tempo, ha collaborato con molti fra i più noti poeti contemporanei, italiani e stranieri, per la realizzazione di letture pubbliche, manifestazioni ed eventi dedicati alla poesia. Ha all’attivo numerose pubblicazioni.Nel 2001 e nel 2006 è stato tradotto in Spagna. Per Scrittura Creativa Edizioni ha pubblicato: Urbanità (2001) Non luoghi A Procedere (2003) Utópos (2005) Bar (2006) Distribuzione(2008)
Alberto Mori, poeta performer e artista, in più di vent’anni di attività ha costruito e alimentato una personale attività di ricerca nella poesia, utilizzando di volta in volta altre forme d’arte e di comunicazione, dalla prosa alla performance, dall’installazione, al video e alla fotografia. Nello stesso tempo, ha collaborato con molti fra i più noti poeti contemporanei, italiani e stranieri, per la realizzazione di letture pubbliche, manifestazioni ed eventi dedicati alla poesia. Ha all’attivo numerose pubblicazioni.Nel 2001 e nel 2006 è stato tradotto in Spagna. Per Scrittura Creativa Edizioni ha pubblicato: Urbanità (2001) Non luoghi A Procedere (2003) Utópos (2005) Bar (2006) Distribuzione(2008)Performate
Scrittura Creativa Edizioni, 2010
Euro 12
lunedì 7 febbraio 2011
Storia di Rifondazione Comunista (II)

Quali sono le prospettive per la sinistra nel momento del tramonto della Seconda Repubblica? C'è ancora spazio per una alternativa di sistema?
Partito o Movimento? Storia di Rifondazione Comunista
Seconda parte
Il Partito della Rifondazione Comunista rimase inchiodato ad una percentuale inferiore a quella del 1992 (4,7%) e vide sfumare ogni velleità di superare indenne la crisi dell'autunno precedente.
Nello stesso spazio politico, intanto, si era insediato un concorrente pericoloso, che amplificava nelle urne l'effetto della scissione.
Soprattutto, però, il Partito della Rifondazione Comunista scoprì l'estrema debolezza del suo rapporto con l'elettorato di riferimento.
Ciò che è importante, a questo punto, far notare, è che la sconfitta fu interpretata dalla leadership come un evento addebitabile all'inadeguatezza del modello organizzativo a quel punto a disposizione del partito.
Soprattutto l'inadeguatezza della propria organizzazione fu esplicitamente paragonata alla maggiore adeguatezza rispetto ai processi di “americanizzazione” della politica, da parte di modelli organizzativi agli antipodi, come le organizzazioni leggere e allo stesso tempo completamente leaderizzate.
Allora fu posto, esplicitamente, il problema dell'efficacia dell'azione del partito territoriale e furono lanciate alcune campagne che si proponevano di stimolare una azione della base, modulata su campagne “single issue” tipiche di formazioni senza una struttura articolata come quella che il Partito della Rifondazione Comunista aveva ereditato dalla tradizione del movimento operaio.
Il tema dell'innovazione organizzativa si collocò al centro del V congresso del partito, sulla base di un nuovo tipo di rapporto tra partito e movimento “no – global”.
L'irrompere di questo nuovo soggetto nell'ambiente politico italiano, surriscaldò la temperatura interna al partito, mettendo di nuovo in discussione la stabilità e la coesione della coalizione dominante interna.
La proposta formulata allora dalla leadership (già anticipatrice di quella successiva relativa alla “non violenza”) rappresentò un punto di vera e propria innovazione al riguardo della tradizionale impostazione dei partiti comunisti.
Il Partito della Rifondazione Comunista propose, così, la sua internità al movimento ribaltando la tradizionale posizione di subalternità che la dottrina leninista (ma non solo) assegnava al movimento rispetto al partito.
Fu apertamente sconfessata l'idea che il partito dovesse tenersi distaccato dal movimento e fornirgli una coscienza politico – ideologica.
Al contrario la leadership del Partito della Rifondazione Comunista concettualizzò il nuovo soggetto di movimento come parte di una nuova sinistra alternativa, che avrebbe dovuto contenere sia il Partito della Rifondazione Comunista, sia l'insieme dei soggetti sociali e politici che stavano muovendosi contro la “globalizzazione liberista”.
In questo senso il movimento era concepito come una leva per scardinare il sistema bipolare e ampliare lo spazio politico da “terza forza” del partito.
I fattori- chiave dell'impianto organizzativo
I fattori chiave che, inizialmente, hanno modellato l'impianto organizzativo del Partito della Rifondazione Comunista possono essere individuati nell'impulso determinante di alcuni leader carismatici ed in uno sviluppo per “penetrazione/diffusione” territoriale.
Il Partito della Rifondazione Comunista si è caratterizzato, dunque, per uno sviluppo di tipo misto, ma con la prevalenza di uno sviluppo per diffusione territoriale, anche se di tipo particolare.
Da una parte, infatti, si è assistito ad un processo in cui l'appello unificatore del gruppo di “imprenditori politici” che avevano lasciato il PCI, coagulò una galassia di gruppi locali germinati nel corso del processo di scioglimento del vecchio partito.
Dall'altra parte, ed oggi appare l'elemento determinante, l'organizzazione nacque attraverso la fusione di una pluralità di leader nazionali e locali che controllavano le proprie reti organizzative, consolidatesi prima della creazione del nuovo partito, e che proprio su queste reti fondavano le loro aspirazioni alla leadership.
Dunque, all'interno del Partito della Rifondazione Comunista, sono sempre stati presenti componenti e strati d'elite che esprimevano idee, interessi e culture organizzative differenti.
L'equilibrio tra queste componenti si è rivelato difficilmente stabilizzabile, ed ha dato luogo a continui conflitti per il controllo del partito.
Proprio durante la fase di maggiore consolidamento strutturale la leadership del Partito della Rifondazione Comunista ha tentato di aumentare il controllo sull'ambiente operativo del partito.
Con l'elaborazione della linea delle “due sinistre” e la teorizzazione della lotta per l'egemonia tra sinistra di governo e sinistra antagonista, il “centro” del partito realizzò un'articolazione dei fini (Panebianco 1982) che fondava la legittimità della leadership sull'espansione del territorio di caccia del partito, oltre la semplice nicchia dell'opposizione e della difesa dell'identità comunista.
Di fatto, l'analisi del dibattito interno e della strategia del partito, in quella fase, hanno mostrato l'esistenza di un rapporto tra variazioni della coalizione dominante interna e delle modalità con cui, fino ad allora, il partito si era rapportato con l'ambiente esterno.
Nelle fasi in cui la coalizione dominante interna riusciva faticosamente a raggiungere un suo equilibrio, pur rimanendo divisa in frazioni organizzate, il partito tendeva a chiudersi in difesa delle posizioni conquistate.
Fatta eccezione per i primissime mesi di espansione organizzativa, durante i primi due anni di esistenza, il Partito della Rifondazione Comunista sembrava seguire questa linea d'azione.
Sia la base del partito che il suo gruppo dirigente si rinserrarono nella difesa della “diversità comunista” e l'organizzazione apparve entrare in una fase di stasi strutturale.
Successivamente è stata perseguita, da un lato, una strategia di espansione, attraverso una apertura dei confini organizzativi ai nuovi soggetti che via, via, andavano comparendo nell'ambiente operativo del partito: in definitiva, attraverso una strategia di dominio dell'ambiente.
Dall'altro lato, emergeva una strategia mirante alla difesa degli equilibri interni già raggiunti, che vedeva come una minaccia alla stabilità interna, qualsiasi allargamento dei confini dell'organizzazione e che perseguiva l'adattamento ambientale.
E' chiaro come queste due strategie abbiano comportato anche una differente visione del necessario grado di confini organizzativi, con i sostenitori del secondo corso d'azione più inclini ad elevare barriere verso l'esterno e a sorvegliare maggiormente il reclutamento.

Il modello organizzativo
Per tutto il dopoguerra il PCI ha rappresentato l'esempio più “puro” di partito di massa operante nel panorama politico italiano.
Il PCI disponeva di una forte articolazione verticale delle strutture organizzative, di una centralizzazione dei processi interni, di un'ampia e ramificata burocrazia rappresentativa, di una subordinazione del gruppo parlamentare agli organi dirigenti, di un forte controllo delle organizzazioni collaterali, di una capacità di inquadramento “morale ed intellettuale” della propria membership: queste erano le caratteristiche fondamentali che rendevano il “partito nuovo” un esempio particolarmente calzante di “istituzione forte”, autonoma rispetto all'ambiente nazionale e dotata di una elevata coerenza strutturale interna.
Se, dunque, vi sono pochi dubbi al riguardo della collocazione del PCI, all'interno della tradizionale distinzione fra differenti tipologie di partiti, la caratterizzazione del Partito della Rifondazione Comunista, sotto questo aspetto si presenta certamente più difficile.
Sicuramente si può affermare che l'organizzazione del Partito della Rifondazione Comunista presenta un assetto fortemente decentrato, quasi federativo, ma con una significativa eccezione: il processo di selezione delle candidature, sempre fortemente accentrato nelle mani di un vertice ristretto.
La posizione della leadership nazionale all'interno del partito non ha mai, invece, goduto (fino ad ora) di quella autonomia tattica, che era invece consentita alla leadership comunista grazie al “centralismo democratico”.
Altre due variabili strutturali importanti per caratterizzare il modello organizzativo del Partito della Rifondazione Comunista sono la professionalizzazione del partito ed il tipo di sistema di finanziamento (Tan, 1997, Katz e Mair 1994 – 1995).
Il Partito della Rifondazione Comunista è un'organizzazione in cui il lavoro volontario dei militanti ha ancora un certo peso nel garantire il funzionamento dell'organizzazione su vari fronti( attività politica extra – elettorale, candidature per le cariche pubbliche, lavoro volontario durante le campagne elettorali, ecc).
Tuttavia, per comprendere il ruolo del processo di professionalizzazione nella struttura del partito, si deve distinguere una professionalizzazione di tipo “burocratico – partitico” (la classica burocrazia rappresentativa od esecutiva, diffusa nei partiti di massa) da una professionalizzazione che potremmo definire di tipo istituzionale, derivante cioè dall'occupazione di ruoli pubblici di autonome risorse selettive.
Questo secondo elemento, della professionalizzazione di tipo istituzionale ha avuto, come vedremo, un ruolo molto importante anche nel definire gli schieramenti congressuali nel 2008, all'indomani dalla fuoriuscita forzata dal Parlamento e, successivamente, nell'orientare i termini della nuova scissione che ha portato fuori dal partito lo stesso ex-segretario Bertinotti e causato una forte crisi nel quotidiano “Liberazione”.
Altra caratteristica molto importante per delineare il modello strutturale del partito è rappresentata dalla virtuale assenza di organizzazioni sociali fiancheggiatrici, e quindi dal bassissimo grado di controllo organizzativo esercitato dal partito sul proprio ambiente esterno.
Se, dunque, la struttura organizzativa che caratterizza il Partito della Rifondazione Comunista è difficilmente inquadrabile all'interno delle tradizionali dicotomie partito di massa/ partito pigliatutti, oppure partito burocratico di massa/ partito elettorale professionale, come possiamo definire il modello organizzativo adottato da partito?
Per le caratteristiche suaccennate, la natura organizzativa del Partito della Rifondazione Comunista può essere accostata a quella di un moderno partito di quadri (modern cadre party, Koole, 1992, 1994).
Un modello organizzativo che, se da un lato, si distingue per le sue caratteristiche strutturali democratiche dal classico partito di quadri ottocentesco (Duverger 1964), dall'altro lato per via delle ridotte dimensioni della membership porta a concepire questo partito come un canale utile soltanto per i membri attivi, piuttosto che per l'integrazione politica delle masse (Koole, 1992 , 1994).

La scelta dell'area di governo, il fallimento della Lista Arcobaleno e la scissione di SEL
Abbiamo già avuto modo di far rilevare come l'entrata in scena di un nuovo soggetto, il cosiddetto movimento anti globalizzazione, ha fatto emergere l'asse su cui sta ruotando il conflitto tra i vari schieramenti, rimettendo in gioco la definizione dei confini dell'organizzazione e il rapporto tra partito e movimento.
E' andata in discussione, nel periodo tra il 2001 ed oggi, l'identità di un partito in cui si mette l'accento sulla necessità di uscire da un rapporto troppo stretto con la tradizione organizzativa ed elettorale del vecchio PCI, per esplorare nuovi potenziali terreni di caccia, rappresentati da una nuova generazione che si ritiene orientata a sinistra (in questo senso, ad esempio, il dibattito sulla nonviolenza, in adesione ai fermenti di tipo cristiano presenti nel movimento pacifista) mentre la leadership preparava la svolta di governo.
In questo quadro è così precipitata la scelta, compiuta con il congresso di Venezia del 2005, di approdo organico alla formazione di uno schieramento di centrosinistra destinato -nel caso di un prossimo successo elettorale – ad alternarsi al governo, in luogo dello schieramento di centrodestra.
Questa scelta, compiuta a maggioranza e pagando il prezzo di un ulteriore inasprimento nel contesto delle difficoltà di relazione già instauratesi da tempo nella coalizione dominante interna fino al punto di provocare, nell'immediata vigilia delle elezioni del 2006, una ulteriore scissione dell'ala trotzkista che ha formato il partito Comunista dei lavoratori, si collegava, prima di tutto, al tentativo di semplificazione dell'offerta politica contenuta nel tentativo di semplificazione del sistema contenuta nella proposta di formazione del PD (già “in fieri” al momento dello svolgimento della tornata elettorale del 2006) e nella modifica della legge elettorale del 2005, in direzione proporzionale con premio di maggioranza e l'introduzione di diversi livelli di soglia di sbarramento. In quel momento il Partito della Rifondazione Comunista (saltando la mediazione offerta dalla prospettiva di una più ampia alleanza di tipo “radical”, formata da altri soggetti quali sinistra DS, Comunisti Italiani, Ecologisti) offriva aderendo in pieno al meccanismo maggioritario esercitato in funzione della governabilità e di personalizzazione della politica, da un lato una copertura sul terreno delle istanza programmatiche considerate più avanzate (pacifismo, situazione sociale ed economica, critica dell'Europa liberista, precarietà del lavoro, ecc..) e dall'altra parte una posizione di “ascolto” e di “interpretazione” dei movimenti, in una sorta di ruolo del partito quasi “border – line” tra democrazia delegata e democrazia partecipativa, anche attraverso una modificazione del sistema di riferimento a livello locale, sotto forma di “rete”.
L' operazione cadeva in una fase di persistente incompiutezza nelle forme definite del sistema politico italiano dove, nella sostanza, il tipo di bipolarismo sorto all'indomani della grande trasformazione del sistema verificatosi attorno agli anni'90 del secolo scorso, pareva, invece non corrispondere più alle fratture sociali dominanti.
Per questo motivo l'offerta politica presentata dai due schieramenti di centrodestra e di centrosinistra, apparve più frammista di quanto non apparisse dallo svilupparsi delle polemiche giornalistiche e televisive.
L'indeterminatezza dei profili programmatici dei due poli è stato causa, quindi, di un limitato interscambio sul piano elettorale, e, di conseguenza, ha originato il risultato elettorale del 2006, con una disparità di maggioranza tra Camera e Senato , cui seguì la profonda incertezza nell'azione di governo del centrosinistra, fino al rapido esaurirsi della legislatura.
Rifondazione Comunista fallì completamente l'obiettivo prefisso e che abbiamo cercato, fin qui, di riassumere, non riuscendo ad interpretare la radicalità politica necessaria per realizzare una attività funzione di governo, e mostrandosi subalterna, complessivamente, anche rispetto alle istanze di movimento, generando una forte ambiguità sul terreno sociale, poi pesantemente pagata anche sul piano elettorale.
Le elezioni del 2008, con la scelta della Lista Arcobaleno, furono il frutto dell'idea di tornare a recitare un ruolo egemone e di “cerniera” tra le varie istanze politiche della sinistra e la realtà sociale, mantenendo diverse identità: non fu compiuta, insomma la scelta che -eppure e nonostante la sconfitta dell'ipotesi governativa – era già matura di offrire una possibilità di ricomposizione politica, sotto l'aspetto di una proposta di nuova soggettività, per la quale – essendosi formato il PD su basi di ambiguità e debolezza ancora maggiori – potevano aprirsi spazi politici particolarmente interessanti.
In questo errore ebbe un peso fortissimo, lo ripetiamo, l'idea di autoconservazione propria di piccoli nuclei dirigenti, emersi senza un vero e proprio processo di selezione di quadri,bensì per cooptazione fidelizzata: fidelizzazione dovuta alla presenza di incentivi selettivi di grande portata.
Il PRC aveva, nel frattempo aderito completamente all'ipotesi maggioritaria di personalizzazione della politica partecipando anche, con suoi esponenti, alle elezioni “primarie”, sia in sede nazionale, sia in sede locale, indette dal PD per suffragare la propria idea del “partito liquido” e della “vocazione maggioritaria”.
Il dato più importante, però, nell'itinerario di “spiazzamento” del PRC dalla possibilità di incidere direttamente sulla vicenda politica italiana ed internazionale è derivato, però, dall'esplodere della crisi economica: crisi economica che ha riportato in primo piano elementi di analisi politica e di progettualità che erano stati accantonati, accettando attraverso la funzione “interna” al movimento “no global” l'idea della marginalizzazione liberista, cui opporsi – per l'appunto – dall'interno, rinunciando ad elaborare un diverso modello di sviluppo, una diversa idea del ruolo dello Stato e delle relazioni internazionali (pensiamo al ritardo nella costruzione dell'Unione Europea): nulla di diverso, comunque, dal tipo di crisi che ha colpito i partiti della sinistra europea (Linke compresa se guardiamo ai risultati elettorali del 2009) tutti raccolti in una accettazione acritica del “liberalismo” temperato.
Oggi la risposta che il residuo politico ancora operante nel PRC ( risultato, è bene ricordarlo di 5 scissioni consecutive: Comunisti Unitari nel 1995, Comunisti Italiani nel 1998, Comunisti Lavoratori nel 2006, Sinistra Critica nel 2008, Movimento per la Sinistra nel 2009) non può essere semplicemente quella del ritorno all'opposizione extraparlamentare e ad una sorta di massimalismo molto somigliante alla “prima” DP (con un ruolo, nell'alleanza elettorale, tutto da decifrare da parte del PdCI che, nel frattempo, perso Cossutta ha subito un'altra – sia pure marginale – scissione “da destra”).
Nell'eventualità del realizzarsi di questa ipotesi ,che pure – al di fuori da qualsiasi del tutto involontaria ingenerosità di giudizio – mi pare quella uscita vincente dall'ultimo congresso, Rifondazione Comunista potrebbe ritrovarsi in una condizione di vera e propria marginalità, rispetto ad un progetto di rilancio di una nuova soggettività politica della sinistra che è necessario si ponga, complessivamente, un obiettivo unitario, uscendo da quella dimensione di subalternità e di assenza di autonomia che, appaiono, in questo momento i veri limiti “trasversali” per tutti i partiti e movimenti che si collocano in quest'area politica, priva, oltre tutto, di capacità di rappresentanza istituzionale.
Rinunciando a partecipare a questo processo o, peggio, pretendendo di egemonizzarlo senza avere capacità di elaborazione e di quadri per muoversi in questa direzione, il Partito della Rifondazione Comunista si troverebbe a dover rinunciare ad un modello organizzativo orientato verso la produzione di una spinta organica verso la trasformazione della società, attraverso una classica funzione politico – pedagogica, riducendosi ad una sorta di movimento “radical” all'americana, e, di conseguenza, ad una funzione di mera sopravvivenza organizzativa.
A questa analisi di due anni fa circa occorrerebbe aggiungere una riflessione sulla ulteriore scissione operata da SEL: in questo senso le ultime frasi del testo del 2009 mi pare possano essere considerate come valide, forse approssimate per difetto: Sel, infatti, è ancora qualcosa di diverso dal movimento "radical" all'americana (che costituisce comunque il riferimento più probante in questa fase, anche per i soggetti sbrigativamente identificabili come “noglobal” e al quale si stanno accostando anche pezzi di sindacato “resistente”, si veda il confronto tra FIOM, precari della scuola, ecc, ecc, sulla linea “uniticontrolacrisi” e la posizione che sembra esprimersi in dimensione maggioritaria sulle colonne del “Manifesto”) avendo introiettato anche gli elementi fondativi del "partito personale", esasperando se possibile i tratti distintivi portati avanti dalla leaderhisp di Rifondazione Comunista tra il 2001 ed il 2008 (con un gruppo dirigente del PRC allora e di SeL adesso per il quale vale riprendere le dizioni di “cooptazione fidelizzata” e fidelizzazione dovuta alla presenza di incentivi selettivi di grande portata, dovuti pressochè esclusivamente al ruolo di “affabulatore” del leader. Rimane dunque tuttora da dibattere e da includere nell'agenda politica il tema di una nuova soggettività della sinistra italiana, intesa come partito radicato sul territorio, strutturato organizzativamente, in grado di produrre assieme capacità di coesione sociale e politica ed egemonia culturale, ed un programma di coerente alternativa sulla linea di una vera e propria “diversità di sistema”.